Nel 2012 sono state – tra paganti e non – ben 36,4 milioni le persone che hanno varcato le porte dei musei italiani senza contare quelli, non rilevati, che si sono recati alle tante mostre temporanee che non sempre si svolgono negli spazi museali.
Si tratta di visitatori – come diverse indagini mostrano – con una buona propensione alla spesa su servizi (bar e ristorazione), per l’acquisto di libri (dal catalogo, alle monografie, dalle cartoline ai manifesti) e interessati al merchandising che si trova esposto nelle strutture museali.
Tuttavia il modo in cui sono stati gestiti negli ultimi vent’anni i così detti «servizi aggiuntivi» rappresenta una delle tante occasioni perse del nostro Paese per valorizzare i beni culturali come leva di sviluppo di un segmento editoriale (e di merchandising) con forte vocazione alla «qualità» e all’internazionalizzazione (si veda l’e-book Il ritratto dell’arte. Rapporto sull’editoria d’arte 2013 disponibile on line).
Il flusso di visitatori strettamente «paganti» rimane sostanzialmente costante e oscilla attorno ai 16 milioni di persone. Diverso, invece, l’andamento del flusso di ingressi complessivi che passano dai 34,5 milioni (del 2006) ai 36,4 milioni del 2012 (sono quasi due milioni di visitatori in più!). In ogni caso aumentano gli incassi complessivi derivanti dalla bigliettazione dei musei (+8,7% e + 2,6% tra 2011 e 2012), anche se la spesa media rimane del tutto irrisoria (attorno a 3 euro a visitatore), ed appare lontana dai valori di spesa di analoghe istituzioni straniere.
Tanto più che la stima delle vendite nei bookshoop museali si attestava nel 2012 a circa 18 milioni di euro (-10% sull’anno precedente) pari all’1,3% del mercato trade (inteso in senso allargato: edicole, fiere, ecc.).
Ovviamente non è solo una questione di visitatori perché alla base di queste performance del sistema museale italiano ci sono alcuni elementi strutturali che non si è saputo (o voluto) modificare.
Il pubblico nel museo
digital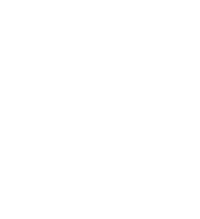


Articolo
| Rivista | Giornale della Libreria |
| Fascicolo | Febbraio 2014 |
| Titolo | Il pubblico nel museo |
| Autore | Emilio Sarno |
| Editore | Ediser |
| Formato |
|
| Pagine | 0 |
| Genere |
Varie Indagini |
| Online da | 01-2014 |
| Issn | 1124-9137 (stampa) | 2385-118X (digitale) |
Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:
-
Android
-
E-Book Reader
-
Ibs Tolino
-
Kobo


















