«Le copertine sono morte!» grida Craig Mod dal suo e-book Reinventare le copertine (Apogeo, 2013). Sono morte «perché il modo in cui noi tocchiamo il libro digitale è differente dal modo in cui tocchiamo il libro fisico». Affermazione difficile da confutare. Così come difficile è anche evadere la domanda: quale «funzione mantengono le copertine digitali dopo l’acquisto, ma soprattutto prima»?
Sottotraccia – ma neppure tanto – il peccato di cui le copertine (e i grafici che le hanno disegnate) si sarebbero macchiati: «nei libri, il design delle copertine si è evoluto massicciamente in uno strumento
di marketing». Quello che mi pare certo è che le copertine dei libri sono cambiate in rapporto a due elementi: le trasformazioni che sono avvenute nei canali di vendita e i cambiamenti nel comportamento d’acquistodei lettori. Sono cambiate qualche volta in meglio, altre volte in peggio. Ma questa è solo una questione di sensibilitàgrafica e di sensibilità editoriale.
Con la trasformazione della libreria in una libreria a libero servizio (per le librerie Feltrinelli, parliamo ad esempio degli anni ’60), le copertine aniconiche della vecchia Bur o della PBE Einaudi hanno iniziato ad avere sempre minor ragione d’essere perché l’acquisto nel 54% delle vendite stava diventando d’impulso. Le librerie a loro volta iniziavano ad essere alle prese con la crescita dell’offerta (da 8 mila si passa a oltre 30 mila novità) e a un’esposizione dell’assortimento da editore ad argomenti che disintegra la linea grafica della collana.
In librerie sempre più grandi, poi, la copertina – oltre a costituire uno strumento di merchandising per il punto vendita, contribuendo ad «arredarlo» – è chiamata a svolgere un ruolo ancor più determinante
nell’arrestare davanti a sé il cliente. E allora, siamo nel decennio scorso, è tutto uno spuntare di visi (femminili) e di occhi che ci guardano. Come per le riviste di moda o le pubblicità cercano di sedurci incontrando i nostri sguardi di clienti distratti.
Meta-cover
digital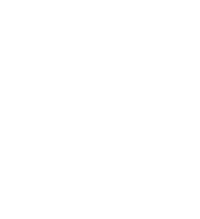


Articolo
| Rivista | Giornale della Libreria |
| Fascicolo | Novembre 2013 |
| Titolo | Meta-cover |
| Autore | Giovanni Peresson |
| Editore | Ediser |
| Formato |
|
| Pagine | 0 |
| Genere |
Storie dell'editoria Varie Editori |
| Online da | 01-2013 |
| Issn | 1124-9137 (stampa) | 2385-118X (digitale) |
Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:
-
Android
-
E-Book Reader
-
Ibs Tolino
-
Kobo


















