Alzi la mano chi si ricorda di aver letto una recensione di un libro di manualistica in una delle tante pagine letterarie che popolano quotidiani e settimanali italiani. Alla meno peggio può essere capitato di scorgere qualche segnalazione e qualche box, con copertina e comunicato stampa, per lo più relegati nella «sottocategoria» della stampa femminile o in quella di servizio.
Conseguenza, non ultima, questa dei bassi indici di lettura che contraddistinguono il nostro Paese. Se non si percepisce il libro e la lettura non solo come un momento di «evasione», di «svago», di «occupazione del tempo libero», ma anche come uno strumento attraverso cui affrontare e risolvere i piccoli/grandi problemi della vita quotidiana (dal giardinaggio al bricolage, dalle pratiche sportive alla cura dell’orto) la manualistica – in tutte le sue declinazioni (viaggi, cucina, ecc.) – finisce per occupare una posizione residuale rispetto agli altri settori della produzione e del mercato editoriale.
Da questo punto di vista, già questa condizione del settore della manualistica, ci dice molte cose sulla qualità della lettura nel nostro Paese ma anche sulla matrice letteraria della comunicazione giornalistica su e attorno al libro. Con tutte le inevitabili ricadute – il classico gatto che si mangia l’altrettanto classica coda – sulla stessa distribuzione e organizzazione degli spazi e degli assortimenti della libreria. Ma anche fuori dalla libreria. Si guarda, infatti, sempre con malcelato stupore a quei pochi negozi – di alimentari di alta gamma, garden center, agenzie di viaggio, casalinghi, ma anche negozi di abbigliamento per bambini ecc. – che espongono piccoli assortimenti di libri e manuali accanto a merceologie inusuali.
Tutta insieme – per dare qualche numero del fenomeno – la manualistica nel 2012 non è composta da più di 6.000 titoli. Il 10% della produzione editoriale complessiva.
Attenzione alla salute!
digital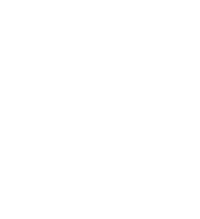


Articolo
| Rivista | Giornale della Libreria |
| Fascicolo | Febbraio 2013 |
| Titolo | Attenzione alla salute! |
| Autore | Emilio Sarno |
| Editore | Ediser |
| Formato |
|
| Pagine | 0 |
| Genere |
Varie Mercato Editoria d'arte Editoria medico-scientifica |
| Online da | 01-2013 |
| Issn | 1124-9137 (stampa) | 2385-118X (digitale) |
Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:
-
Android
-
E-Book Reader
-
Ibs Tolino
-
Kobo


















