Una delle ragioni per cui questa editoria di nicchia è rimasta a lungo nell’ombra – per lo meno in Italia – è il ritardo con cui si è affermato un mercato facsimilare vero e proprio; in secondo luogo, le dimensioni ridottissime del mercato facsimilare in termini di clienti – nessun prodotto è venduto in più di 1.000 esemplari – hanno indotto molti a ignorare questo settore, liquidandolo come un fenomeno marginale legato più all’industria del lusso o al collezionismo che all’editoria.
Ciò che forse ha pesato maggiormente nell’attribuire a questa forma di editoria un carattere extravagante nel panorama editoriale sono le caratteristiche stesse delle opere pubblicate. In effetti i facsimili, riproduzioni perfette di libri antichi (soprattutto manoscritti miniati medievali), si discostano per molti versi dalla concezione del libro stampato contemporaneo: da un lato per il loro elevato costo; dall’altro per la particolarità del processo produttivo, nel quale le fasi di prestampa, stampa e legatura dei volumi sostituiscono la centralità della progettazione dei contenuti tipica dell’editoria.
Questi elementi hanno contribuito a diffondere l’idea del facsimile come un prodotto ambiguo, a metà strada tra il libro e l’oggetto d’artigianato di lusso, in bilico tra la vocazione culturale-scientifica e quella commerciale. Nel frattempo, però, la fisionomia attuale del mercato dei facsimili appare molto diversa rispetto a quella di vent’anni fa.
Una vita in facsimile
digital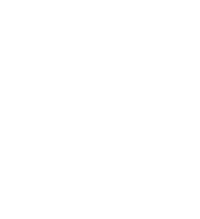


Articolo
| Rivista | Giornale della Libreria |
| Fascicolo | Ottobre 2005 |
| Titolo | Una vita in facsimile |
| Autore | Paolo Bonacini |
| Editore | Ediser |
| Formato |
|
| Pagine | 0 |
| Genere | Editoria d'arte |
| Online da | 01-2005 |
| Issn | 1124-9137 (stampa) | 2385-118X (digitale) |
Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:
-
Android
-
E-Book Reader
-
Ibs Tolino
-
Kobo


















