Quasi come Alice nel Paese delle Meraviglie che rischia di annegare nelle sue stesse lacrime, così le nuove generazioni – ma non solo – sembra che cerchino sempre più prodotti culturali che suscitino in loro tristezza e commozione, come film, musica e soprattutto libri. La dicitura «libri che fanno piangere» spopola sul web e, in particolare, ha trovato terreno fertile su TikTok, dove migliaia di giovani lettori e lettrici condividono le proprie emozioni scaturite dalle letture: #booksthatmademecry ha oltre 370 mila contenuti correlati, #sadbooks più di 150 mila, a cui si aggiungono quelli di tutte le varianti di hashtag simili. Ma perché le persone amano immergersi in storie che le fanno soffrire? Perché si cerca la tristezza?
Breve storia del pianto nei libri
Il rapporto tra lettura e lacrime ha radici antiche e attraversa la storia del romanzo. Un articolo del New Yorker racconta che, nel XVIII secolo, quando il romanzo era ancora una forma letteraria appena nata, piangere era un segno di virtù del lettore. «I romanzi “sentimentali”, ricchi di scene strappalacrime, offrivano a lettori e lettrici l’occasione di esercitare i loro sentimenti più intimi, dimostrando la sensibilità alla sofferenza altrui» riporta la testata. Poi, nel XIX secolo, il significato delle lacrime in letteratura ha preso due direzioni divergenti: da un lato, i romanzi vittoriani usavano la commozione per ispirare una qualche forma di cambiamento sociale; dall’altro, il romanzo «sensazionale» – nato con lo scopo di impressionare e suscitare reazioni fisiche – dimostrava che le emozioni forti potevano essere piacevoli di per sé, anticipando il romanzo moderno. Nel Novecento, la commozione è diventata più estetica e controllata: Nabokov esortava lettori e lettici a «godere con lacrime e brividi», spostando l’attenzione dal sentimentalismo alla soddisfazione artistica.
Le motivazioni psicologiche
Verywell Mind, portale online che fornisce informazioni e supporto nel campo della salute mentale, cerca di spiegare i motivi per i quali le persone cercano storie tristi. Dai film ai romanzi tristi, le storie drammatiche mettono le persone in contatto con le proprie emozioni, permettendo loro di provare gratitudine per ciò che ritengono prezioso o significativo: è un modo per sperimentare alcuni degli aspetti benefici della tristezza senza stress o ansia. Quando si legge, si guarda o si ascolta una storia triste, ci si commuove perché le emozioni che essa trasmette simulano quelle sperimentate nella vita reale.
«La produzione letteraria che ci spinge a piangere può essere preziosa per svariate ragioni» scrive Pepita Sandwich nel saggio illustrato The art of crying (Short Books, 2024; pubblicato in Italia da Sonda con il titolo Piangere. Il potere curativo delle lacrime, tradotto da Maria Teresa Milano). «Può rendere consapevoli su un argomento specifico, aiutarci ad avere empatia per gli altri attraverso la comprensione di quanto pesante sia il loro dolore, superare gli stereotipi e allargare la nostra visione del mondo. Può anche aiutarci a identificare e a liberare le emozioni che ci bloccano e ad approfondire le nostre credenze e convinzioni». Leggere di esperienze dolorose aiuta a riconoscere e accettare anche le proprie fragilità, in un contesto sicuro e protetto. Immergendosi nei sentimenti dei personaggi, si crea un legame empatico condiviso che aiuta a comprendere meglio la complessità della vita e delle emozioni umane.
Lo zampino di TikTok
I ragazzi e le ragazze di oggi vivono in un mondo complesso, segnato da incertezze, ansie e pressioni sociali. In questo contesto, cercano nei libri uno spazio di autenticità, dove le emozioni non siano edulcorate o superficiali, ma raccontate con sincerità e profondità. I libri che fanno piangere rispondono a questo bisogno, offrendo storie che parlano di vita vera, con tutte le contraddizioni del caso. La tristezza diventa così un modo per esplorare la propria interiorità e trovare un senso di appartenenza a una comunità che condivide le stesse emozioni. Per questo motivo, su TikTok, i libri che fanno piangere sono diventati un vero e proprio trend, con hashtag dedicati che raccolgono milioni di visualizzazioni. Giovani lettori e lettrici mostrano le proprie reazioni emotive in video spontanei, creando una comunità di persone che si riconoscono e si sostengono a vicenda. Questa condivisione pubblica amplifica il potere emotivo dei libri, trasformando la lettura in un’esperienza collettiva. E così facendo i giovani trovano conforto nel sapere che non sono soli nelle loro emozioni, che altri le hanno vissute.
«Libri che fanno piangere»: alcuni casi di successo
Il passaparola sui social si trasforma in picchi di vendite. Lo scriveva già nel 2021 il New York Times nell’articolo How crying on TikTok sells books: molte sedi di grandi catene di librerie negli Stati Uniti, già all’epoca allestivano tavoli contenenti i libri virali su BookTok, spesso dalle trame drammatiche, e ad oggi questa è un’abitudine consolidata anche nelle librerie italiane. «Su TikTok non si ha paura di essere aperti ed emotivi riguardo a titoli che fanno piangere, singhiozzare, urlare o arrabbiarsi al punto di lanciarli dall’altra parte della stanza» affermava Shannon DeVito, direttrice della divisione libri di Barnes & Noble. «Il risultato sono video di pochi secondi ricchi di emozioni, nei quali le persone si identificano immediatamente».
Tra i titoli più amati e discussi sulle piattaforme social, BookTok in primis, troviamo ad esempio A little life di Hanya Yanagihara, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti da Doubleday nel 2015 e portato in Italia da Sellerio, con la traduzione di Luca Briasco e il titolo Una vita come tante. Un romanzo drammatico che esplora le vite intrecciate di quattro amici a New York, affrontando temi di amicizia e dolore, che ha commosso migliaia di lettrici e lettori per la sua intensità emotiva ed è diventato un caso editoriale internazionale. In particolare, è uno dei protagonisti, Jude, ad avere la storia più tragica. Alcuni hanno definito esagerato questo accanimento sul personaggio, senza speranza né vie di fuga, sostenendo che le grandi penne debbano fornire soluzioni o aprirci alla possibilità di un miglioramento individuale. Ma – se ne parla qui – la risposta, o la soluzione, che dà Yanagihara è che a volte la cosa più etica che possiamo fare non è migliorare, ma «fare i conti con l’inadeguatezza delle nostre piccole vite».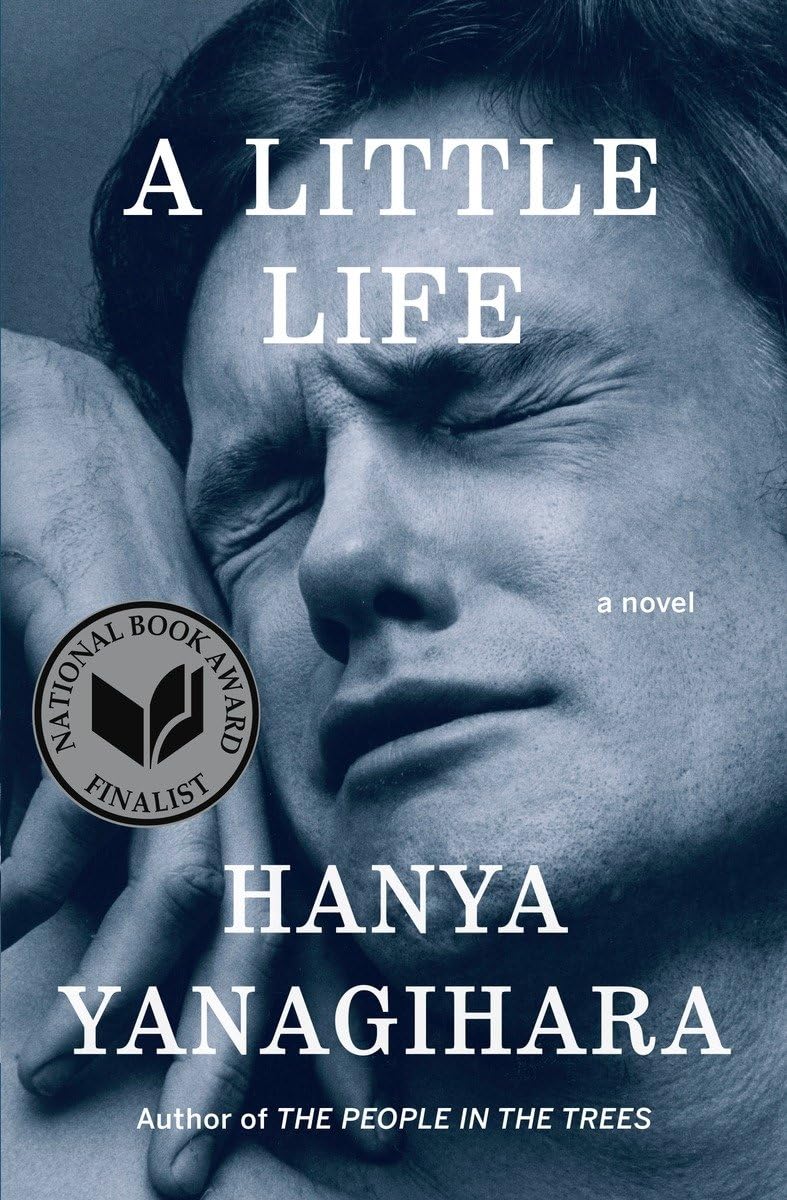
Altri libri diventati best seller che rientrano nell’hashtag «libri che fanno piangere» sono stati, in questi ultimi anni, The song of Achilles di Madeline Miller (HarperCollins, 2011), rivisitazione romanticizzata e tragica della mitologia greca, che racconta l’amore e la perdita tra Achille e Patroclo, capace di toccare il cuore dei giovani. Nel nostro Paese è uscito con il titolo La canzone di Achille: la prima edizione è stata pubblicata nel 2013 dalla casa editrice Sonzogno con la traduzione di Matteo Curtoni e Maura Parolini; successivamente, nel 2019, il libro è stato ripubblicato da Marsilio.
Un caso ancora è It ends with us dell’ormai conosciutissima Colleen Hoover (Atria Books, 2016; in Italia edito da Sperling & Kupfer nel 2022), romanzo che affronta temi delicati come la violenza domestica; oppure They both die at the end di Adam Silvera (HarperCollins, 2017; in Italia pubblicato due anni dopo da Il Castoro con il titolo L’ultima notte della nostra vita, nella traduzione di Chiara Reali), un libro che approccia il tema della morte capace di suscitare forti emozioni e riflessioni soprattutto nel pubblico young adult.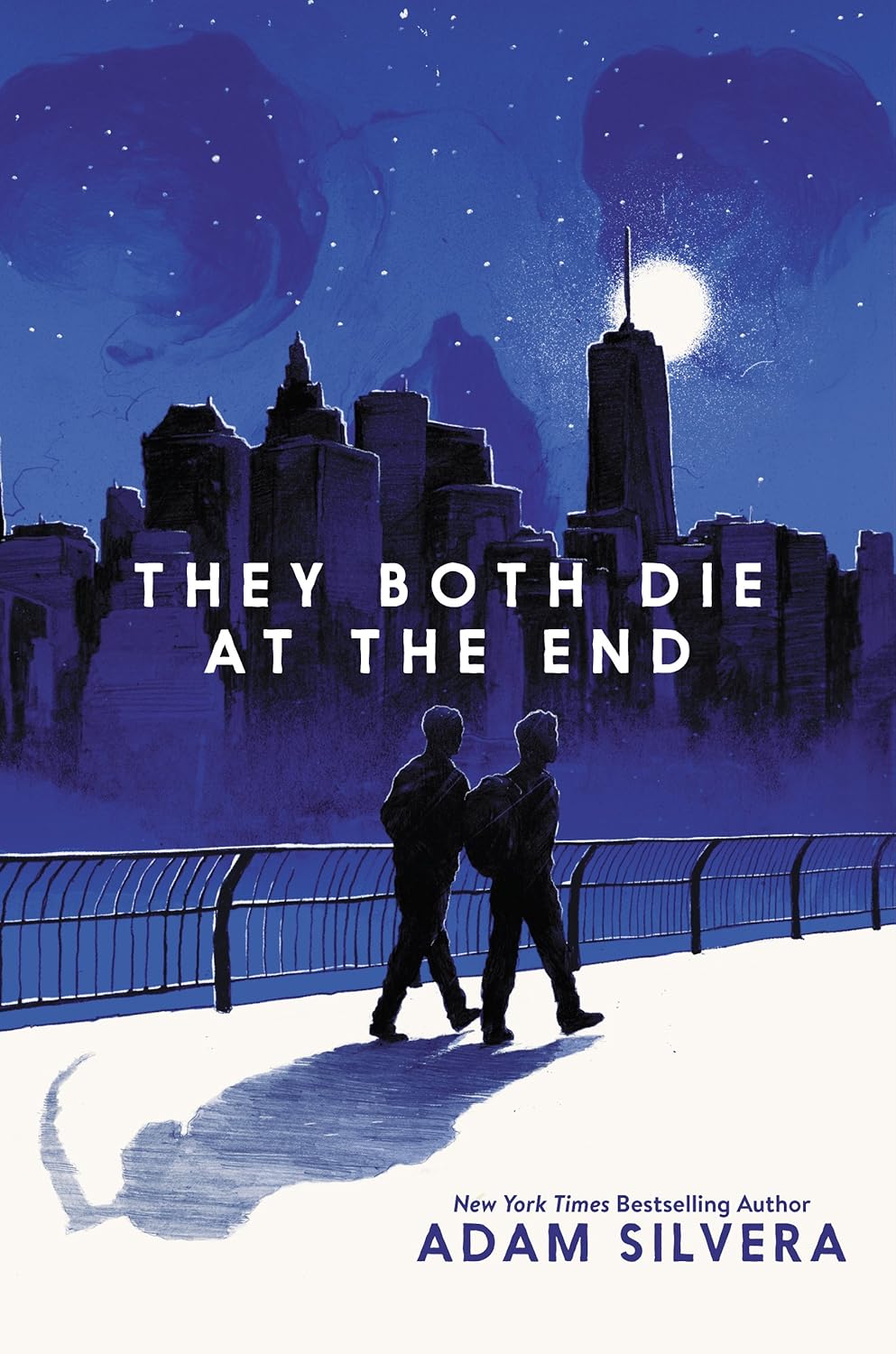
Per la Gen Z piangere è okay
Vedere altri lettori e lettrici commuoversi per le stesse storie rafforza il senso di appartenenza alla comunità lettrice e normalizza la tristezza come parte integrante dell’esperienza di vita. I libri che fanno piangere permettono di esplorare le proprie emozioni, facendo sentire le persone connesse con se stesse e con gli altri. Quando un prodotto culturale suscita una reazione, può aiutare a elaborare esperienze personali o ad affrontare temi complessi. E le nuove generazioni – almeno su TikTok – non hanno paura di mostrarsi umane.
L'autore: Elisa Buletti
Laureata in Lettere all’Università degli Studi di Verona, ho conseguito il master Booktelling, comunicare e vendere contenuti editoriali dell’Università Cattolica di Milano che mi ha permesso di coniugare il mio interesse per i libri e l’intero settore editoriale con il mondo della comunicazione digital e social.
Guarda tutti gli articoli scritti da Elisa Buletti

















