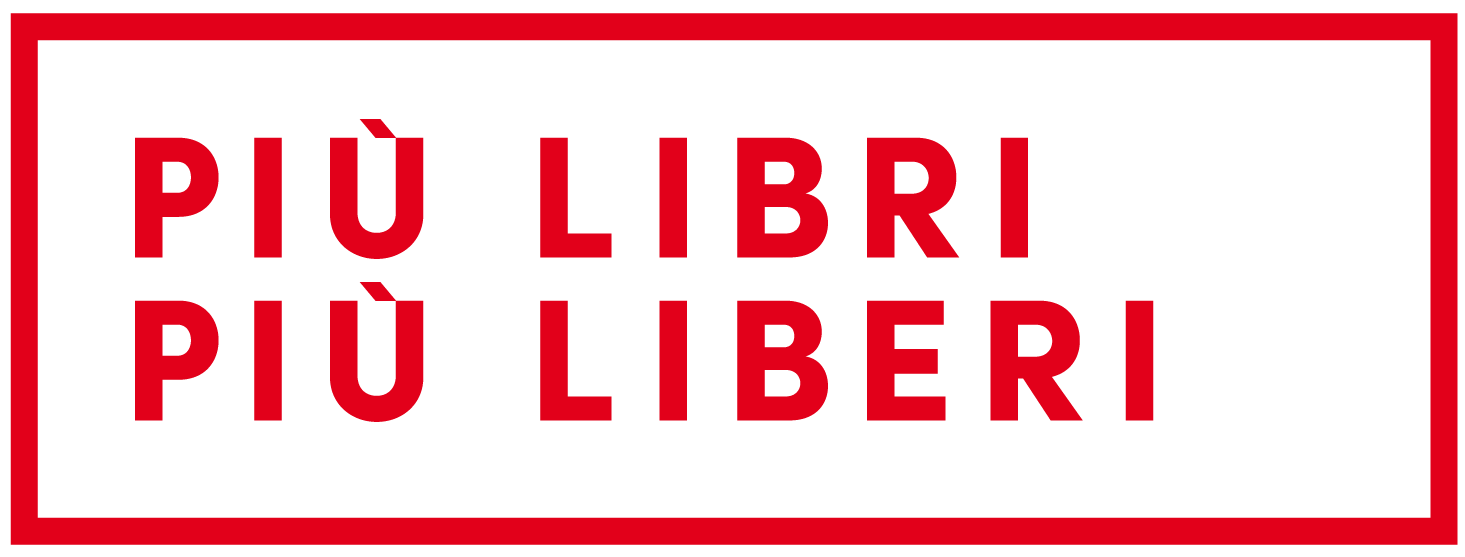
Il Sud e Centro America sono diventati in questi ultimi dieci anni un importante punto di riferimento per le case editrici italiane: per vendere diritti e per comprarli.
Si è passati da uno stentato 1,5% del 2007 come area editoriale da cui comprare i diritti di edizione (sostanzialmente di narrativa) al 2,3% dello scorso anno. Forse sarebbe meglio sottolineare come questa crescita non registri un nuovo interesse a questo mondo, quanto più un ritorno a considerarlo un importante punto di riferimento. Dato che tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso la nostra editoria attraversò una vera e propria stagione e infatuazione per l’editoria e la narrativa sudamericana, spinta anche dal caso di Cent’anni di solitudine, uscito in Italia proprio nel ’68, e del Nobel al suo autore Gabriel Garcia Màrquez. Una stagione fortunata per tutta la cultura che veniva prodotta in quei Paesi e che comprese anche il cinema.
Andando nel dettaglio, questo è il numero di libri i cui diritti sono stati acquistati dagli editori italiani, divisi per singoli Paesi:
E anche considerando l’export di autori e libri italiani in Paesi sudamericani, in dieci anni si passa dal 5,4% all’11,8%, mostrando come l’editoria italiana riesca sempre più a vendersi a mercati poco esplorati finora, considerando Argentina, Brasile, Cile, Messico, ma non solo, come luoghi di destinazione per i nostri libri. Questi i dati più precisi:
Per di più entrambi i dati potrebbero essere sottostimati, in quanto alcune trattative passano sicuramente attraverso case editrici portoghesi o spagnole che operano poi anche sul mercato latino-americano.
Quello che appare importante è la dimensione di reciproco interscambio che può naturalmente passare dalla Bologna Children’s Book Fair o dalla Buchmesse di Francoforte, dal Fellowship di Più libri più liberi o dal MIRC di Tempo di Libri a Milano (nel 2018 sarà dall’8 al 12marzo, tanto più che in Europa sarà la prima fiera dell’anno in cui sarà possibile vendere e comprare diritti), intere fiere internazionali o fiere del libro con aree dedicate alla compravendita di diritti stranieri che sempre più fungono da moderni bazar. Luoghi di scambio che rappresentano un punto privilegiato di osservazione, da cui contestualizzare e scoprire la varietà di offerta editoriale che producono le case editrici di un Paese o di un’intera area geografica e culturale, come in questo caso.
Mi sono sempre occupato di questo mondo. Di editori piccoli e grandi, di libri, di librerie, e di lettori. Spesso anche di quello che stava ai loro confini e a volte anche molto oltre. Di relazioni tra imprese come tra clienti: di chi dava valore a cosa. Di come i valori cambiavano in questi scambi. Perché e come si compra. Perché si entra proprio in quel negozio e si compra proprio quel libro. Del modo e dei luoghi del leggere. Se quello di oggi è ancora «leggere». Di come le liturgie cambiano rimanendo uguali, di come rimanendo uguali sono cambiate. Ormai ho raggiunto l'età per voltarmi indietro e vedere cosa è mutato. Cosa fare da grande non l'ho ancora perfettamente deciso. Diciamo che ho qualche idea. Viaggiare, anche se adesso è un po' complicato. Intanto continuo a dirigere l'Ufficio studi dell'Associazione editori pensando che il Giornale della libreria ne sia parte, perché credo sempre meno nei numeri e più alle storie che si possono raccontare dalle pagine di un periodico e nell'antropologia dei comportamenti che si possono osservare.
Guarda tutti gli articoli scritti da Giovanni Peresson




















