Editori
Negli ultimi anni, chiunque abbia messo piede in una libreria – o chiunque abbia dato un occhio alle classifiche dei libri più venduti – non avrà potuto fare a meno di notare il proliferare a scaffale di un certo tipo di libro: illustrazione di copertina confortevolmente minimalista, gradazioni pastello, ciotole fumanti o stilizzate botteghe nipponiche. Nei titoli, caffè caldi, osterie, librai e librerie, e molti, moltissimi gatti.
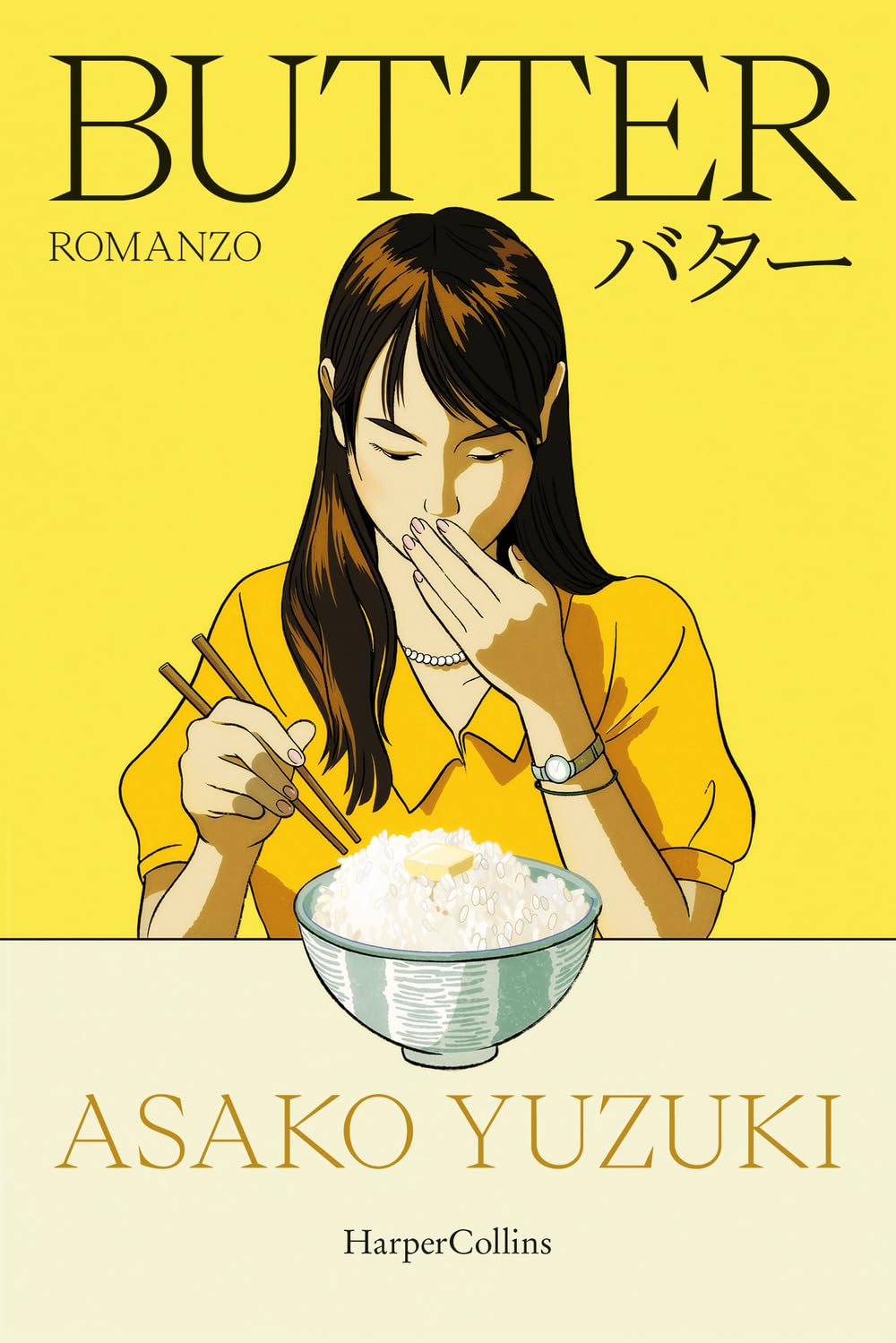
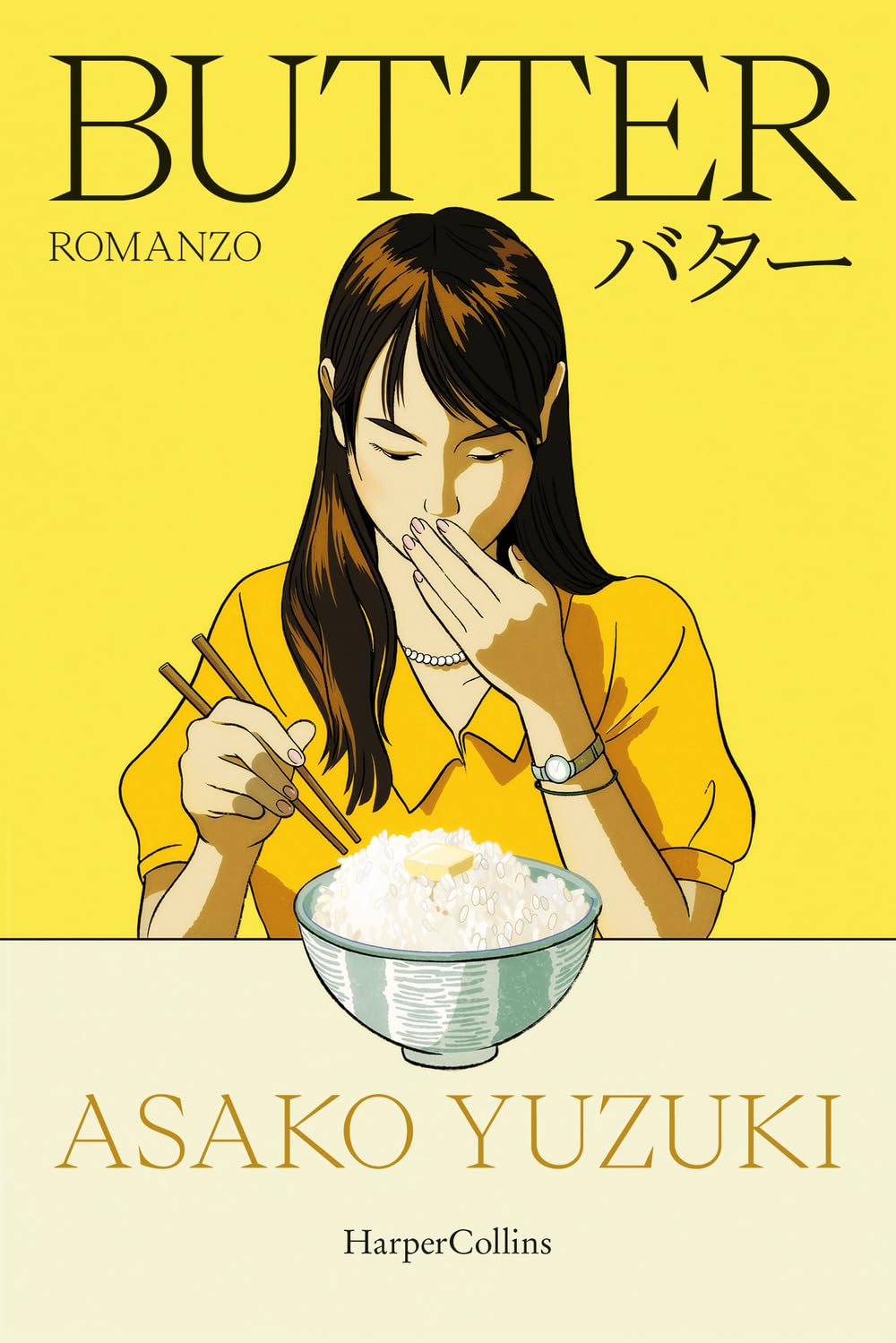
Se ne sono accorti anche al Guardian, rivelando che, se nel 2022 – dati Nielsen BookScan alla mano – il 25% delle vendite di narrativa tradotta nel Regno Unito proveniva dal Giappone, nel 2024 la percentuale sale al 43% tra i 40 titoli più venduti, con Butter di Asako Yuzuki al primo posto. Quest'opera, che mescola critica sociale e narrativa crime, ha conquistato anche il premio Books Are My Bag Readers’ Awards incoronando Yuzuki come autrice rivelazione.
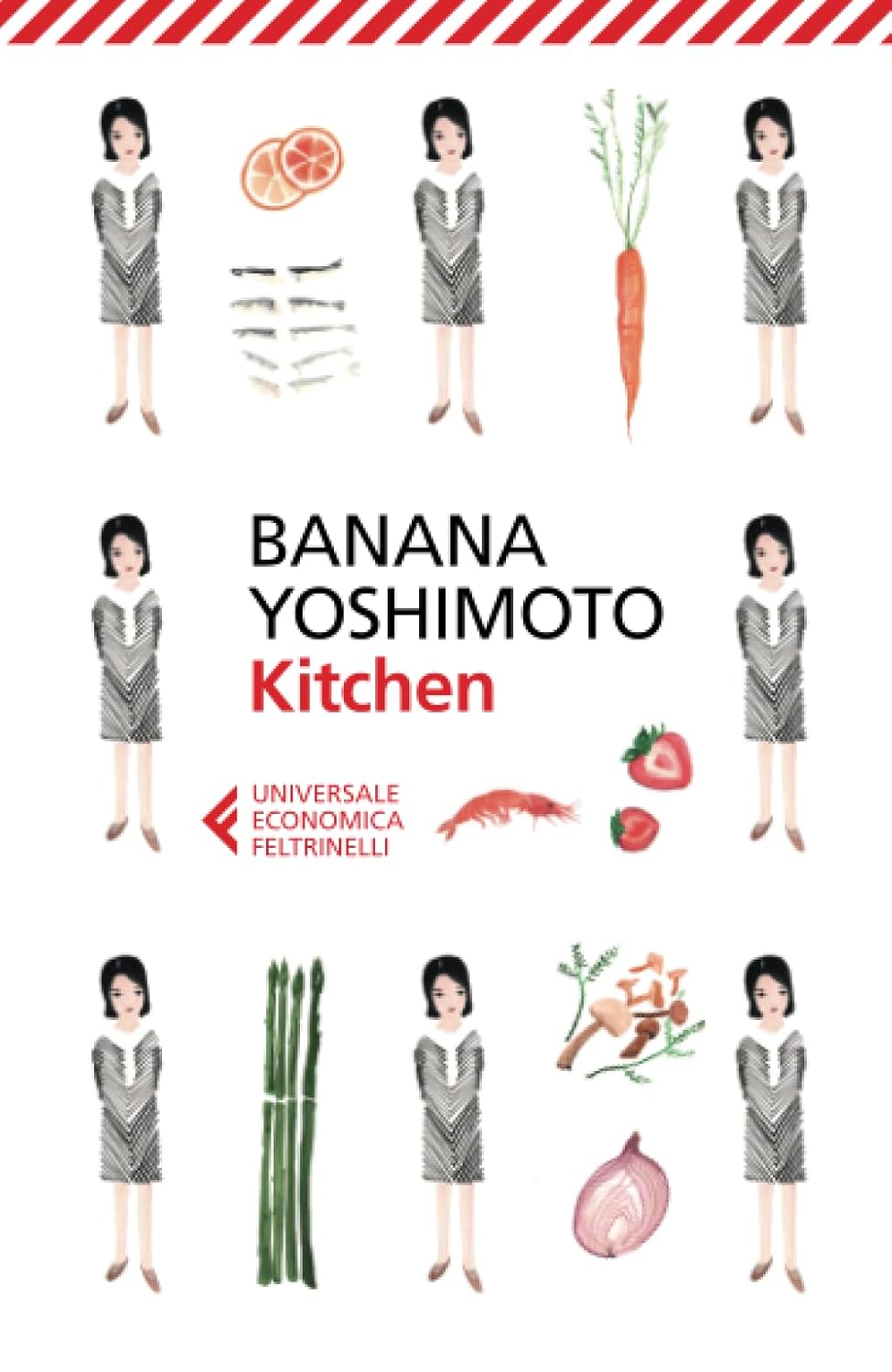
I pionieri: Murakami e Yoshimoto
La popolarità della letteratura giapponese fuori dai confini nazionali non è certo un fenomeno recente. Negli anni ’90, autori come Haruki Murakami e Banana Yoshimoto hanno gettato le basi per il successo odierno. Murakami, autore di culto globale, ha raggiunto la fama nel Regno Unito con L’uccello che girava le viti del mondo, pubblicato nel 1998. Con i suoi protagonisti solitari, atmosfere surreali e temi ricorrenti come gatti, jazz e biblioteche, Murakami ha reso «la stranezza accessibile» secondo Scott Pack, ex responsabile acquisti di Waterstones.
Ma prima di Murakami c’era Banana Yoshimoto, con opere come Kitchen e Lucertola, che esploravano le vite di giovani donne alienate, spesso alle prese con dolori personali. Entrambi gli autori sono stati criticati dal Premio Nobel Kenzaburō Ōe per rappresentare una gioventù apolitica e disillusa, ma il loro impatto sulla narrativa giapponese resta innegabile.
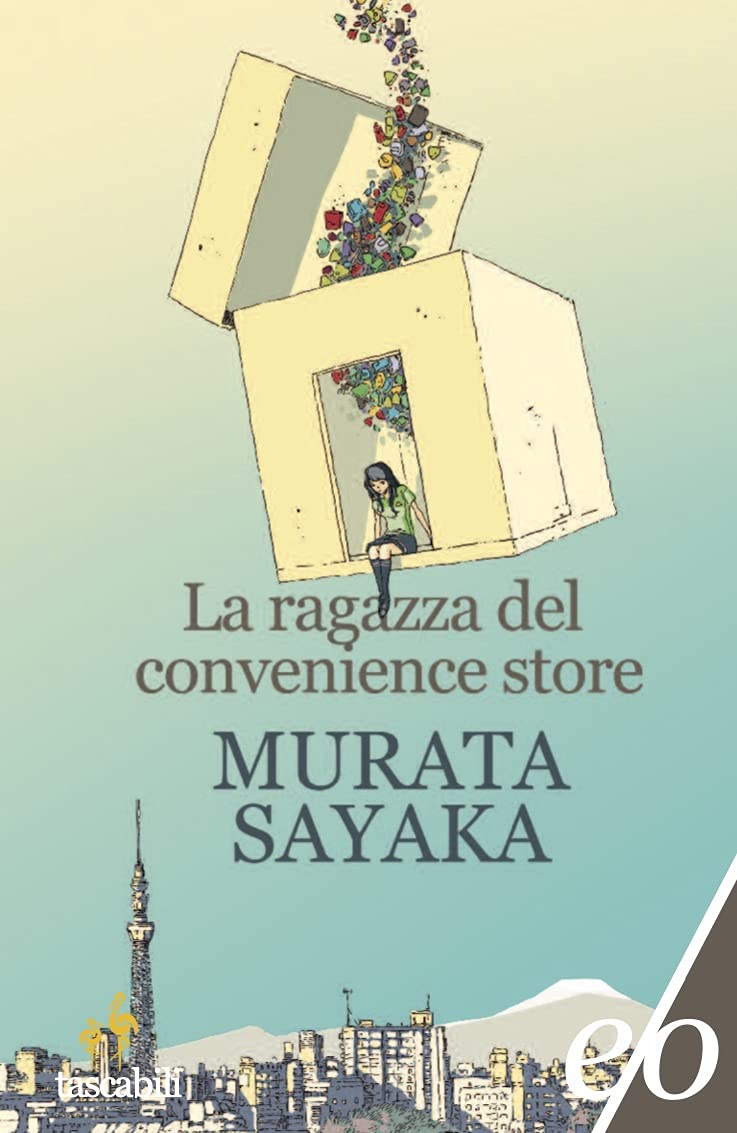
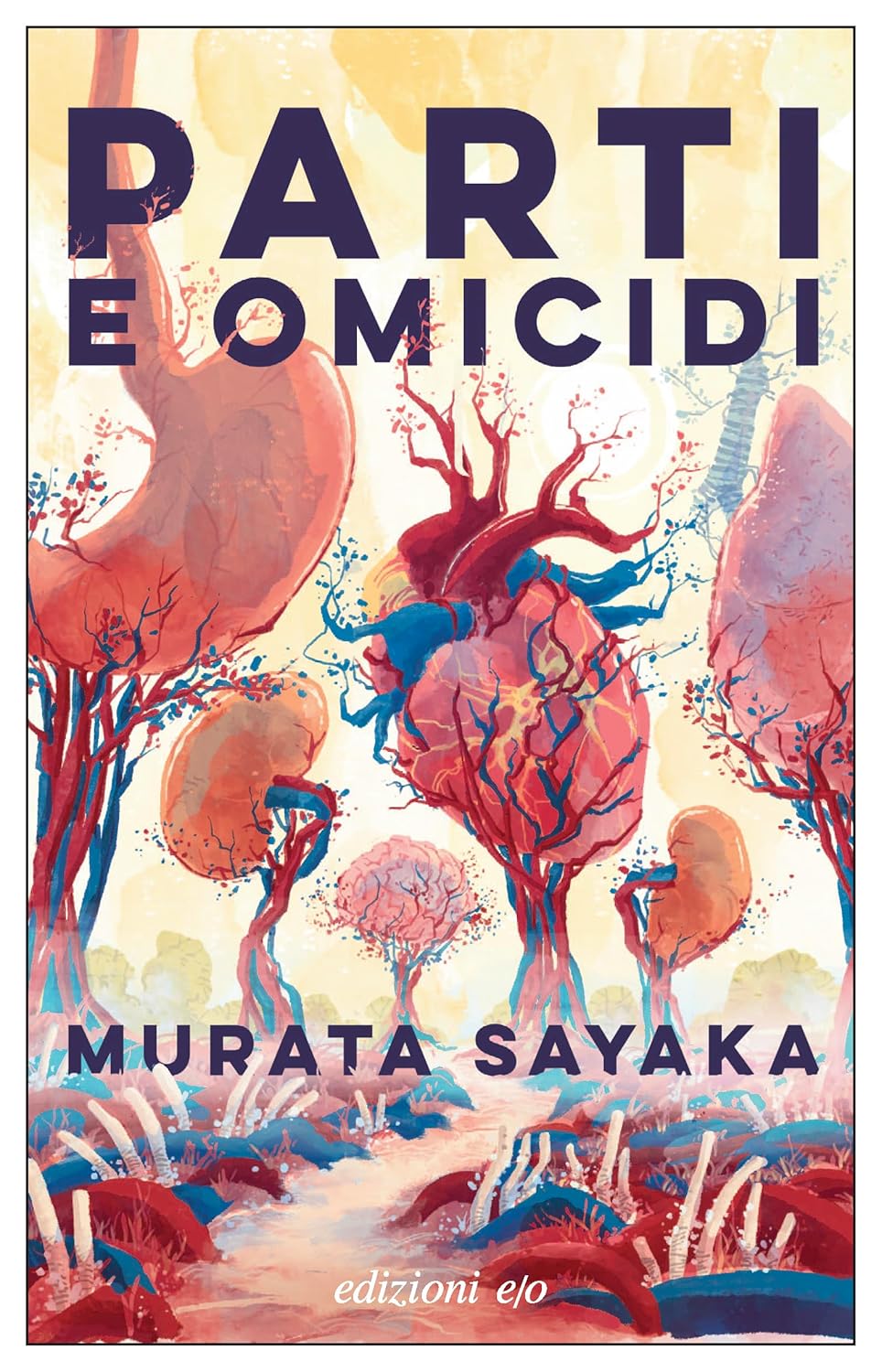
La nuova ondata: Murata e la narrativa «comfort»
L’ultimo decennio ha visto un ampliamento del panorama degli autori giapponesi tradotti. Un momento cruciale è stato il successo di La ragazza del convenience store di Sayaka Murata (2018), che ha venduto oltre mezzo milione di copie e ha aperto la strada a titoli come I terrestri e Parti e omicidi. Murata racconta storie che mettono in discussione ciò che consideriamo «normale», affascinando lettori di tutto il mondo.
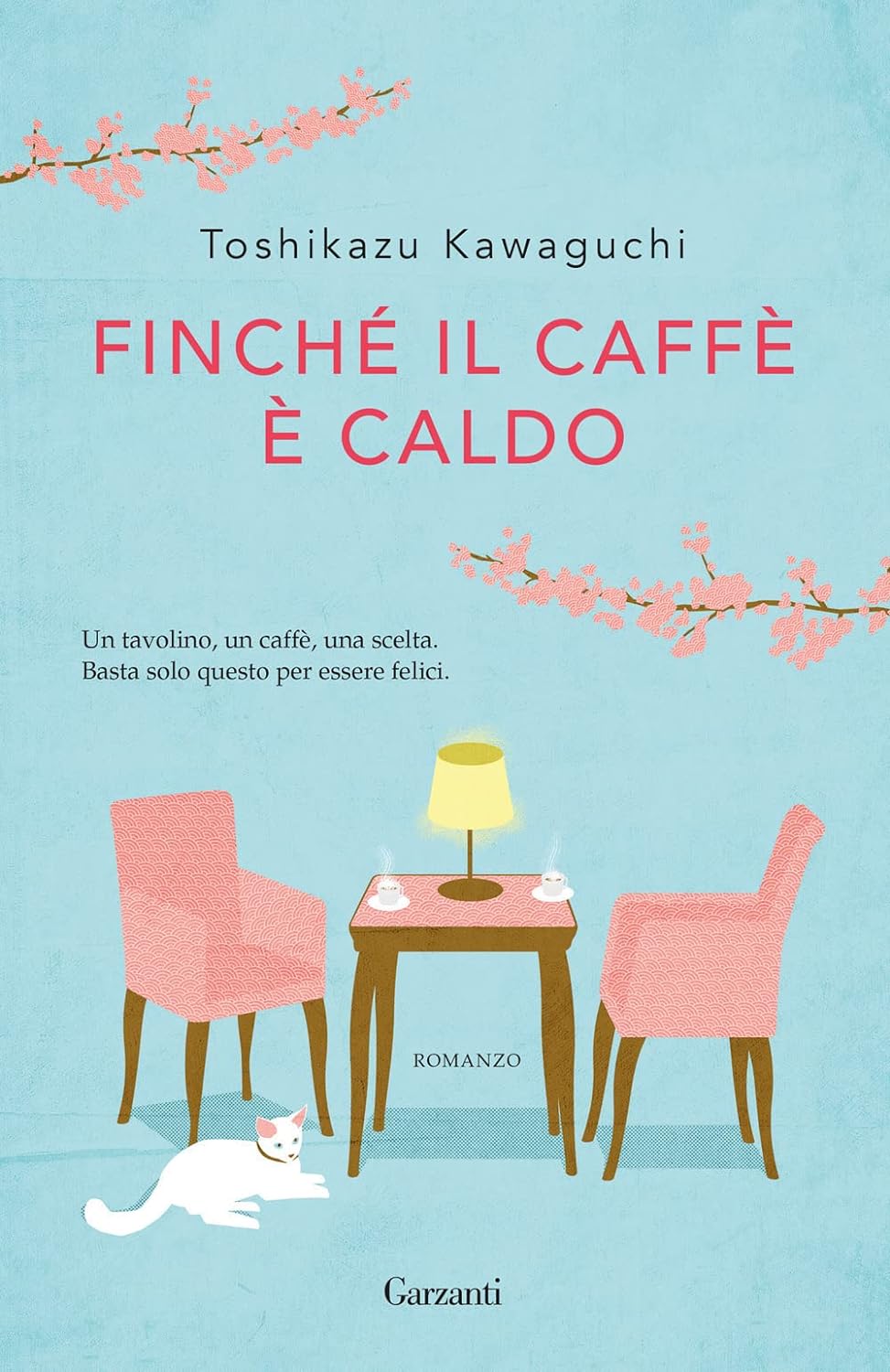

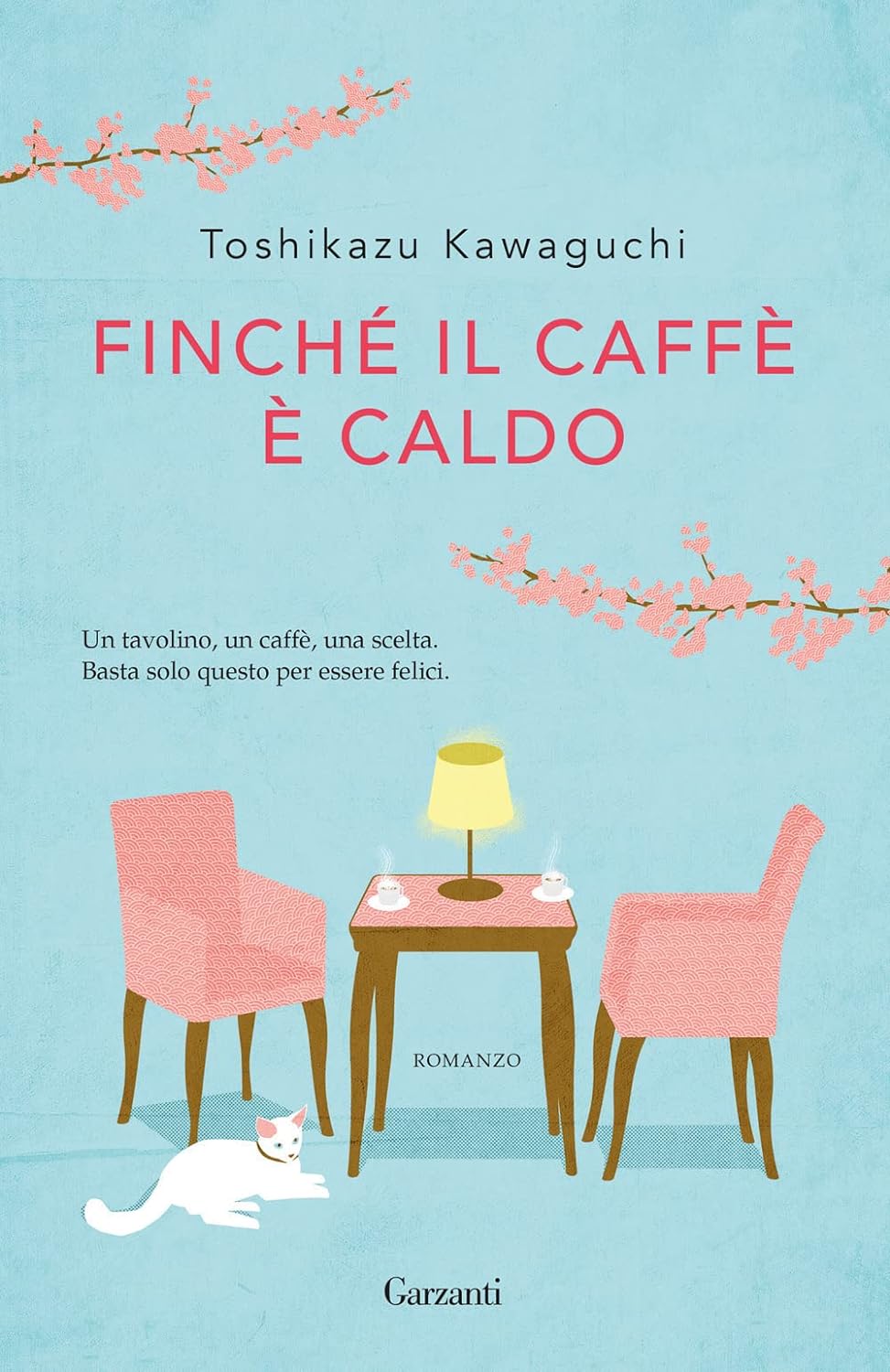

Parallelamente, si è affermato il fenomeno della narrativa comfort giapponese. Libri come Finché il caffè è caldo, di Toshikazu Kawaguchi, Finché non aprirai quel libro, di Michiko Aoyama e Lei e il suo gatto, di Makoto Shinkai, offrono racconti rassicuranti e confortanti che mescolano nostalgia, introspezione e scenari quotidiani.
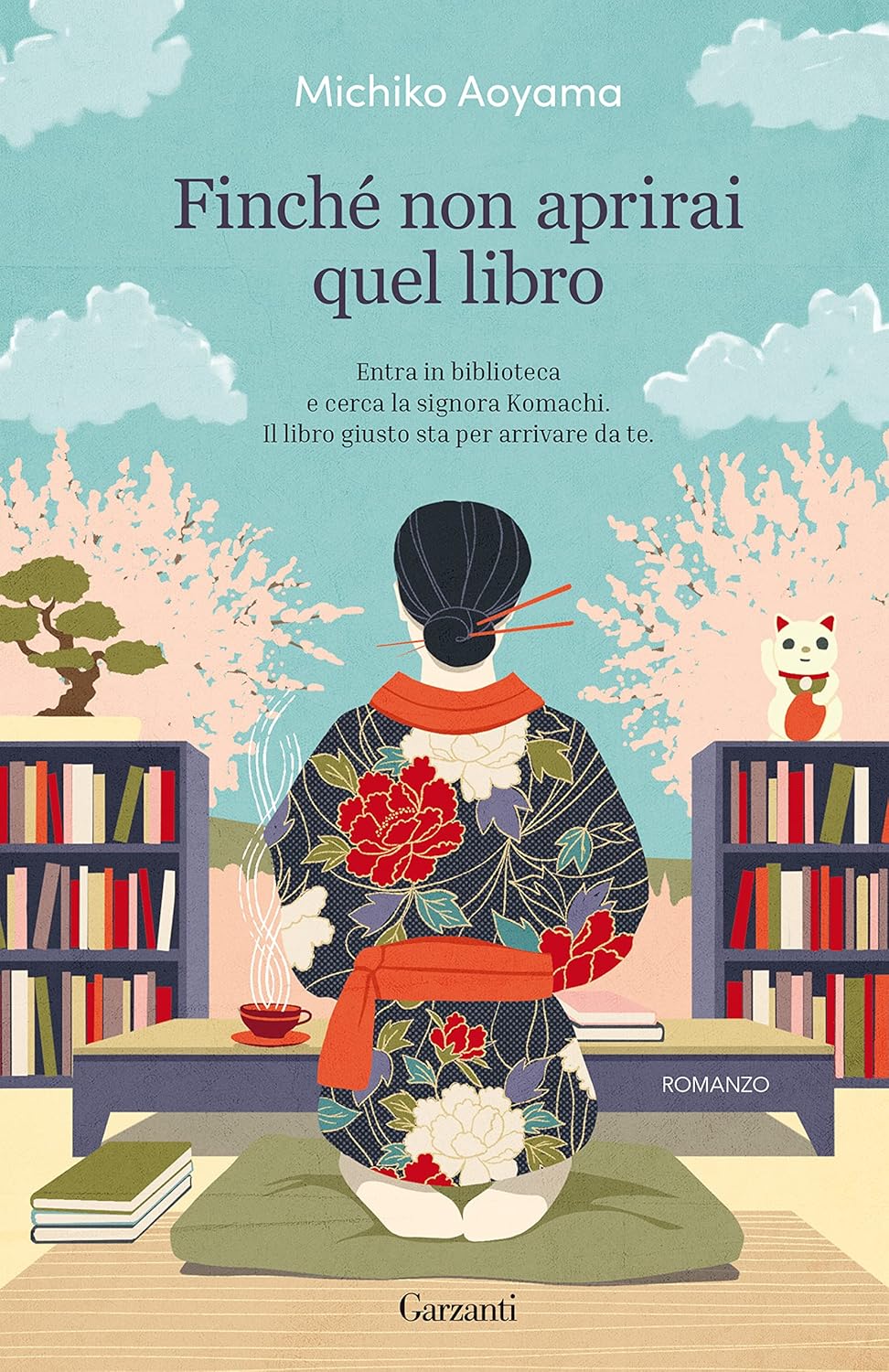
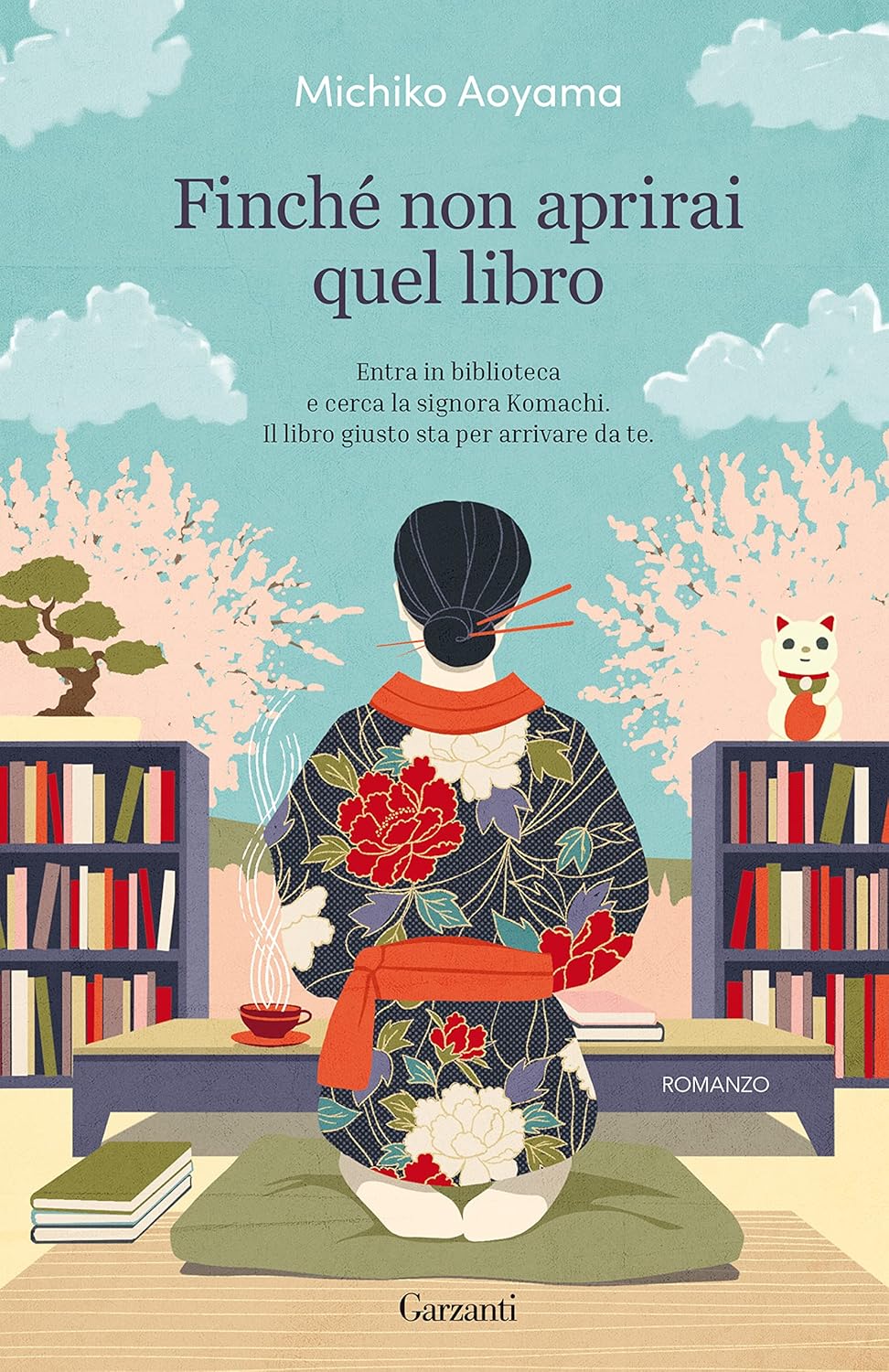
I limiti della selezione editoriale occidentale
Nonostante il successo globale, la narrativa giapponese tradotta è fortemente influenzata dalle tendenze editoriali occidentali. Generi come la fantascienza hard, il soprannaturale, l’horror e i romanzi storici – molto popolari in Giappone – rimangono in gran parte ignorati dai mercati occidentali. Secondo Alison Fincher, curatrice del sito Read Japanese Literature, ciò è dovuto a una «curation pesante» che privilegia tematiche facilmente riconoscibili e assimilabili, come alienazione, comfort e crime.
Perché ci piace l’«alterità confortevole»
Una delle chiavi del successo della letteratura giapponese è la sua capacità di offrire a lettrici e lettori una «alterità confortevole»: un'esperienza esotica ma non troppo distante culturalmente da noi. Inoltre, la narrativa giapponese sfuma spesso i confini tra bene e male, con personaggi complessi e finali aperti, rendendola meno giudicante rispetto alla letteratura occidentale.
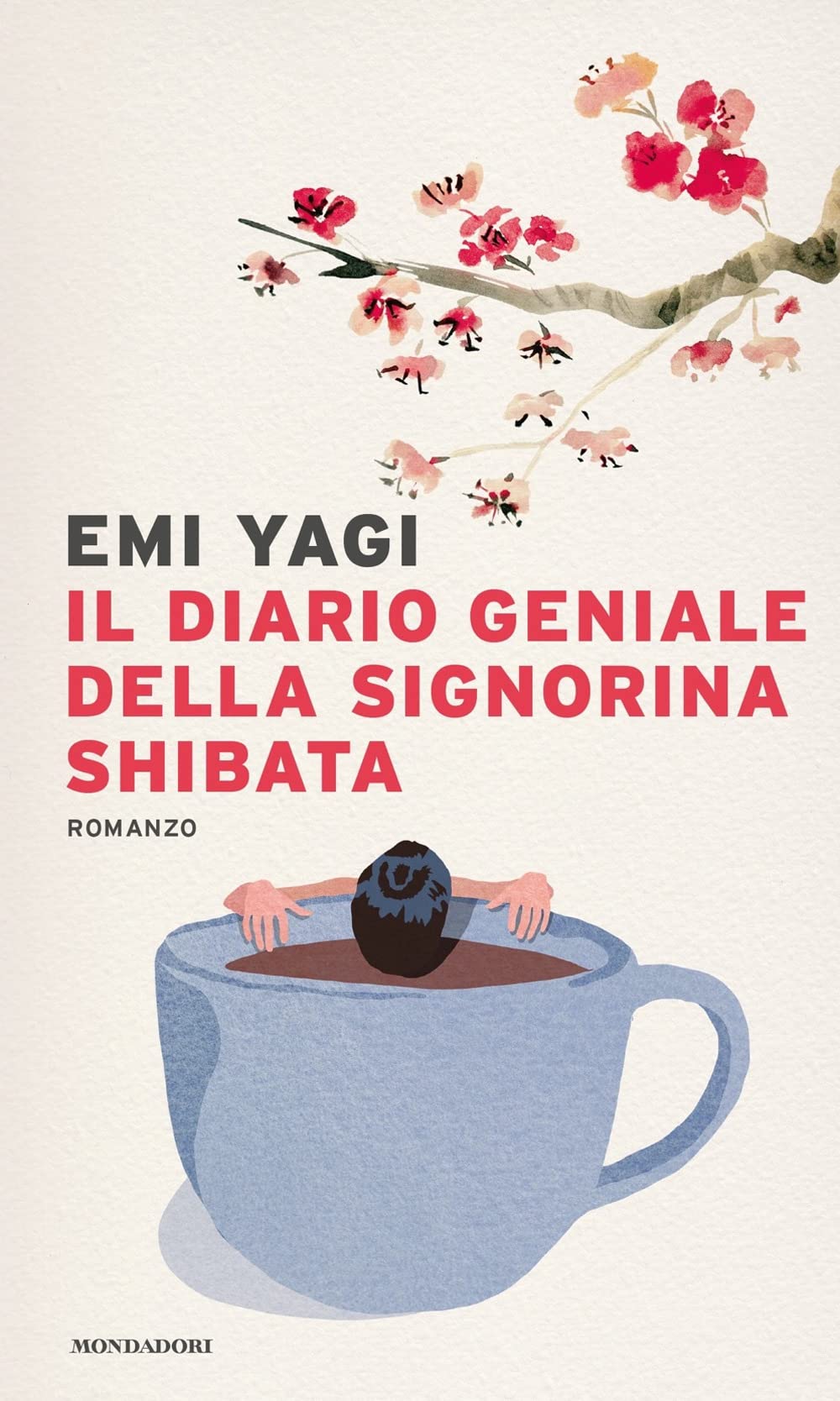
Il futuro della narrativa giapponese tradotta
Come ogni fenomeno editoriale, anche questo boom potrebbe raggiungere il suo apice e calare. Tuttavia, i successi di autori come Murata e Yuzuki dimostrano che la narrativa giapponese ha il potenziale per evolversi e adattarsi. Libri come Il diario geniale della signorina Shibata di Emi Yagi, che affronta tematiche femministe e sociali, potrebbero entrare a pieno diritto nei corsi di studio letterari, consolidando il valore culturale di una produzione editoriale tanto sfruttata commercialmente quanto generalmente poco incisiva nell’immaginario artistico.
Il fascino della narrativa giapponese non risiede solo nella sua capacità di vendere, ma nella sua universalità: parla di ciò che significa essere umani in un mondo complesso. Lasciandoci depositari di un messaggio, se non di serenità, di accettazione: come osserva Murata, «siamo tutti un po’ strani, e la società umana che ci somma tutti lo è ancora di più».
L'autore: Alessandra Rotondo
Dal 2010 mi occupo della creazione di contenuti digitali, dal 2015 lo faccio in AIE dove oggi sono responsabile del contenuto editoriale del Giornale della Libreria, testata web e periodico in carta. Laureata in Relazioni internazionali e specializzata in Comunicazione pubblica alla Luiss Guido Carli di Roma, ho conseguito il master in Editoria di Unimi, AIE e Fondazione Mondadori. Molti dei miei interessi coincidono con i miei ambiti di ricerca e di lavoro: editoria, libri, podcast, narrazioni su più piattaforme e cultura digitale. La mia cosa preferita è il mare.
Guarda tutti gli articoli scritti da Alessandra Rotondo

















