C’è qualcosa di familiare nella «ragazza strana». Nella sua andatura sghemba, nel suo disagio senza redenzione, nella rabbia che esplode nei momenti meno opportuni. Non è un'eroina e non è neanche un'antieroina: è semplicemente disturbante, talvolta repellente. Eppure, la weird girl, con la sua esistenza obliqua e la sua forza anarchica, è diventata una delle figure più interessanti della narrativa contemporanea. Un archetipo che non cerca salvezza né empatia, ma piuttosto una rappresentazione cruda e disadorna del femminile che sfugge a ogni addomesticamento.
La weird girl fiction è il luogo in cui le donne non devono essere piacevoli. Non devono piacere agli altri, ma nemmeno a sé stesse. Spesso non imparano nulla. Non diventano migliori, non fanno i conti con il passato in modo lineare. Se crescono, lo fanno di lato. Il loro arco narrativo non è ascendente: è obliquo, talvolta discendente. Spesso, semplicemente, si spezza. E proprio per questo, paradossalmente, ci restituisce una verità brutale e riconoscibile sull’identità contemporanea. La weird girl è l’eco post-pandemica delle sad girl e delle girlboss che l’hanno preceduta. Ma ha imparato a smettere di provare a scendere a patti con gli altri, a sabotare la sua stessa narrazione, a fare implodere ogni tentativo di riscatto.
La weird girl fiction è il luogo in cui le donne non devono essere piacevoli. Non devono piacere agli altri, ma nemmeno a sé stesse. Spesso non imparano nulla. Non diventano migliori, non fanno i conti con il passato in modo lineare. Se crescono, lo fanno di lato. Il loro arco narrativo non è ascendente: è obliquo, talvolta discendente. Spesso, semplicemente, si spezza. E proprio per questo, paradossalmente, ci restituisce una verità brutale e riconoscibile sull’identità contemporanea. La weird girl è l’eco post-pandemica delle sad girl e delle girlboss che l’hanno preceduta. Ma ha imparato a smettere di provare a scendere a patti con gli altri, a sabotare la sua stessa narrazione, a fare implodere ogni tentativo di riscatto.
Girlboss, sad girl, weird girl
Per comprendere la weird girl fiction, è utile risalire alla genealogia che l’ha preceduta. Negli anni Dieci, la girlboss si imponeva come simbolo di un femminismo affermativo: l’immaginario mediale era punteggiato di ragazze ambiziose, determinate, capaci di parole forti e di dominare la scena con ironia tagliente e sicurezza. A fare da contraltare, la sad girl, malinconica e fragile, con il mascara colato e le poesie postate su Instagram e prima ancora su Tumblr. Da Girls a Normal people, da Lana Del Rey ai meme sul languore autodistruttivo, la sad girl ha incarnato il culto dell’emotività esibita ma non per questo vuota, della vulnerabilità come stile.
La weird girl, oggi, è la loro sorella degenere. Non vuole essere capita, né salvata. È disfunzionale, problematica, talvolta grottesca. È la ragazza che dice cose sbagliate nei momenti sbagliati, che non sa stare al mondo e forse non vuole nemmeno provarci. I suoi modelli non sono le vincenti, ma le scartate. Quelle che hanno rotto qualcosa – dentro o fuori – e hanno deciso di restare a osservare i cocci.
Weird girl tra serie tv e letteratura
Prima che attraverso la letteratura, le weird girl hanno cominciato a popolare il nostro immaginario con le serie tv: in Fleabag la protagonista infrange la quarta parete ma anche ogni regola di autocontrollo e appropriatezza sociale; in I may destroy you, Michaela Coel racconta una ragazza, suo alter-ego, che sopravvive a una violenza riscrivendo da zero le coordinate del trauma; Russian doll gioca con la reiterata morte della protagonista come glitch narrativo; Yellowjackets immagina un’intera squadra di ragazze sbandate, cannibali (un topos dell’horror che sta conoscendo rinnovato successo), sopravvissute e traumatizzate, alle prese con la memoria e con l’istinto. The Bear, Beef, Somebody Somewhere… queste e molte altre serie propongono varianti complesse, scomposte, disturbate e disturbanti della femminilità.
Anche la letteratura contemporanea è piena di weird girl. Pensiamo alla protagonista apatica e solitaria di My year of rest and relaxation di Ottessa Moshfegh (pubblicato in Italia da Feltrinelli con il titolo Il mio anno di riposo e oblio), vero e proprio caposaldo della weird girl fiction. Oppure a Eliza Clark e il suo Boy parts, romanzo in cui una giovane fotografa trasforma la violenza del desiderio in una pratica sadica e narcisistica. Catherine Lacey, Halle Butler, Amina Cain, Isabella Hammad, Megan Nolan, Natasha Brown, Claire-Louise Bennett…: tutte, a modo loro, raccontano personaggi femminili che non si curano di essere likeable. Anzi, spesso fanno di tutto per essere respingenti. Perché la stramberia, la sgradevolezza, il disadattamento diventano modi per sabotare la narrazione dominante sul femminile, ancora troppo spesso vincolata all’ideale di coerenza, maturazione e doverosità del «messaggio positivo».
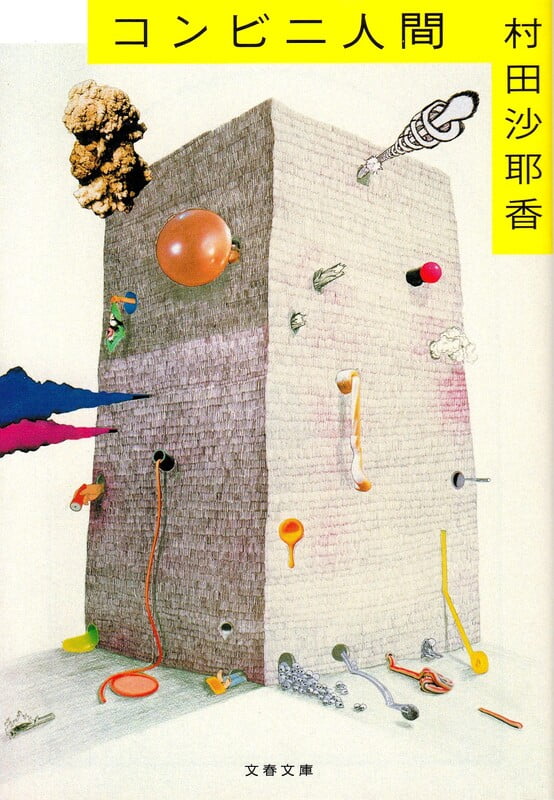 Gaitskill, Murata e le origini della weird girl fiction
Gaitskill, Murata e le origini della weird girl fictionGià nel 1991 Mary Gaitskill, con Two girls, fat and thin (pubblicato in Italia da Mondadori nel 1992, ma adesso fuori catalogo), anticipava questa tendenza narrando di due donne apparentemente opposte unite dall'ossessione per un filosofo controverso. E lo stesso ha fatto, per più di qualche verso, Sayaka Murata, i cui scritti esplorano da due decenni le diverse conseguenze della non conformità alle regole sociali, in particolare per quanto riguarda i ruoli di genere, la genitorialità e il sesso.
Nel 2016, in particolare, Murata è uscita con Konbini ningen (letteralmente «persona konbini», in Italia per e/o con il titolo La ragazza del convenience store), che racconta di Keiko Furukura, 36enne di Tokyo impiegata part-time da diciotto anni in un konbini, un minimarket aperto 24 ore su 24. Fin da piccola, Keiko viene percepita come strana: non comprende del tutto le dinamiche sociali, reagisce in modo anomalo alle emozioni e si sente aliena rispetto alle convenzioni. Avrà modo di rendersi conto che il vero problema non è la sua stranezza, ma l’ipocrisia attorno a lei, che preferisce l'apparenza alla felicità.
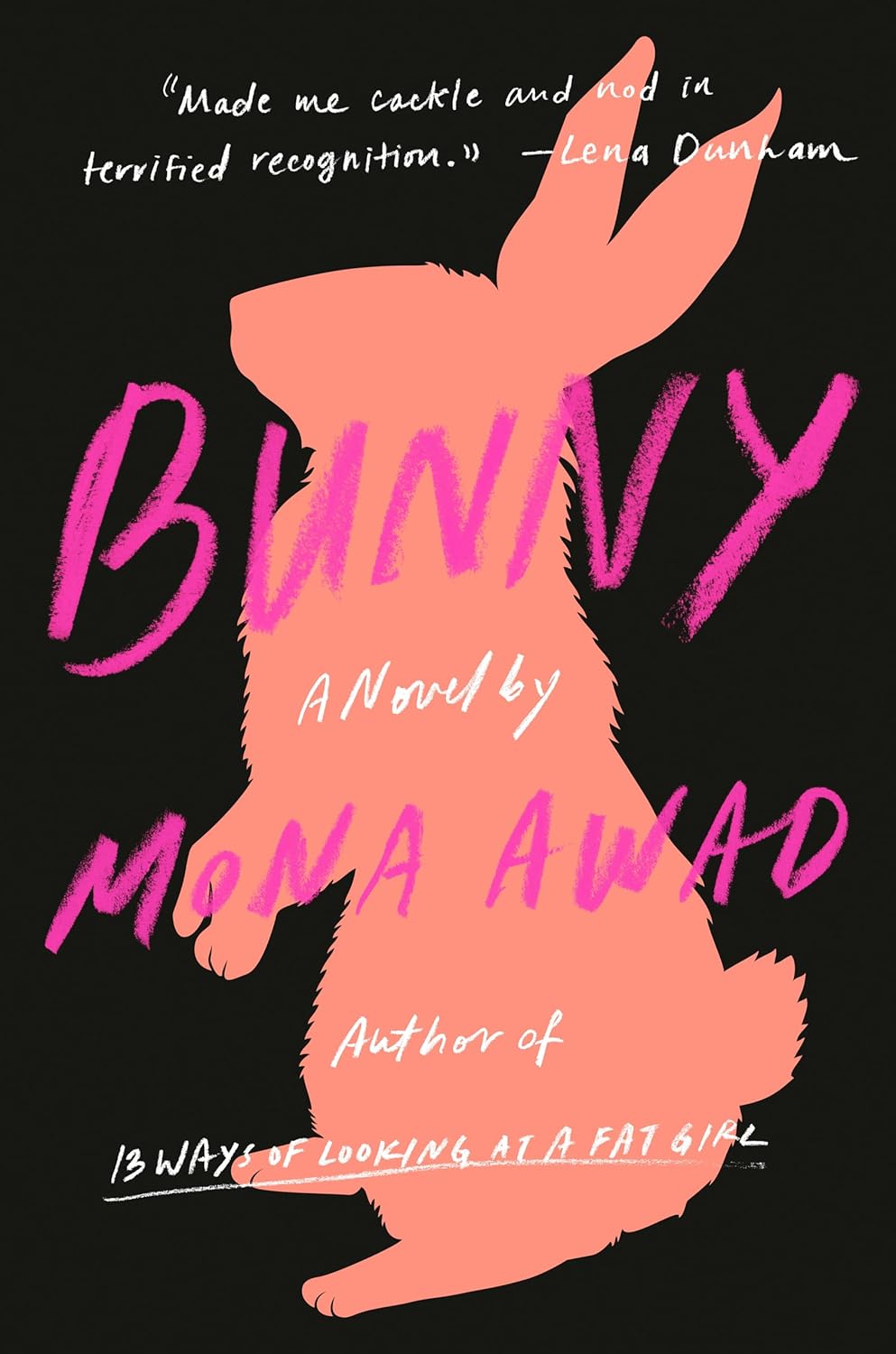 Il mostruoso relazionale
Il mostruoso relazionalePrima della pandemia da Covid, vero acceleratore della «narrativa delle ragazze strane», era uscito anche Animals eat each other, romanzo di esordio di Elle Nash (2017), la cui protagonista — una donna senza nome, diciannovenne — incontra una sera una coppia che la introduce a una relazione non convenzionale, sprofondandola progressivamente in una spirale di dipendenza, gelosia, manipolazione e autodistruzione. Tutti temi presenti anche in Acts of desperation, il romanzo d'esordio di Megan Nolan pubblicato nel 2021 e portato in Italia da NN Editore con il titolo Atti di sottomissione.
Ma la weird girl si manifesta anche in contesti più surreali, come in Bunny di Mona Awad (2019, pubblicato in Italia da Fandango): la studentessa outsider di un prestigioso corso di scrittura creativa viene inspiegabilmente invitata a un evento esclusivo e oscuro, organizzato da un gruppo di ragazze ricche e apparentemente innocue che si fanno chiamare Bunny. Tutto prenderà ben presto una piega imprevista e la protagonista verrà a conoscenza dei «rituali» che trasformano delle placide studentesse in creature mostruose.
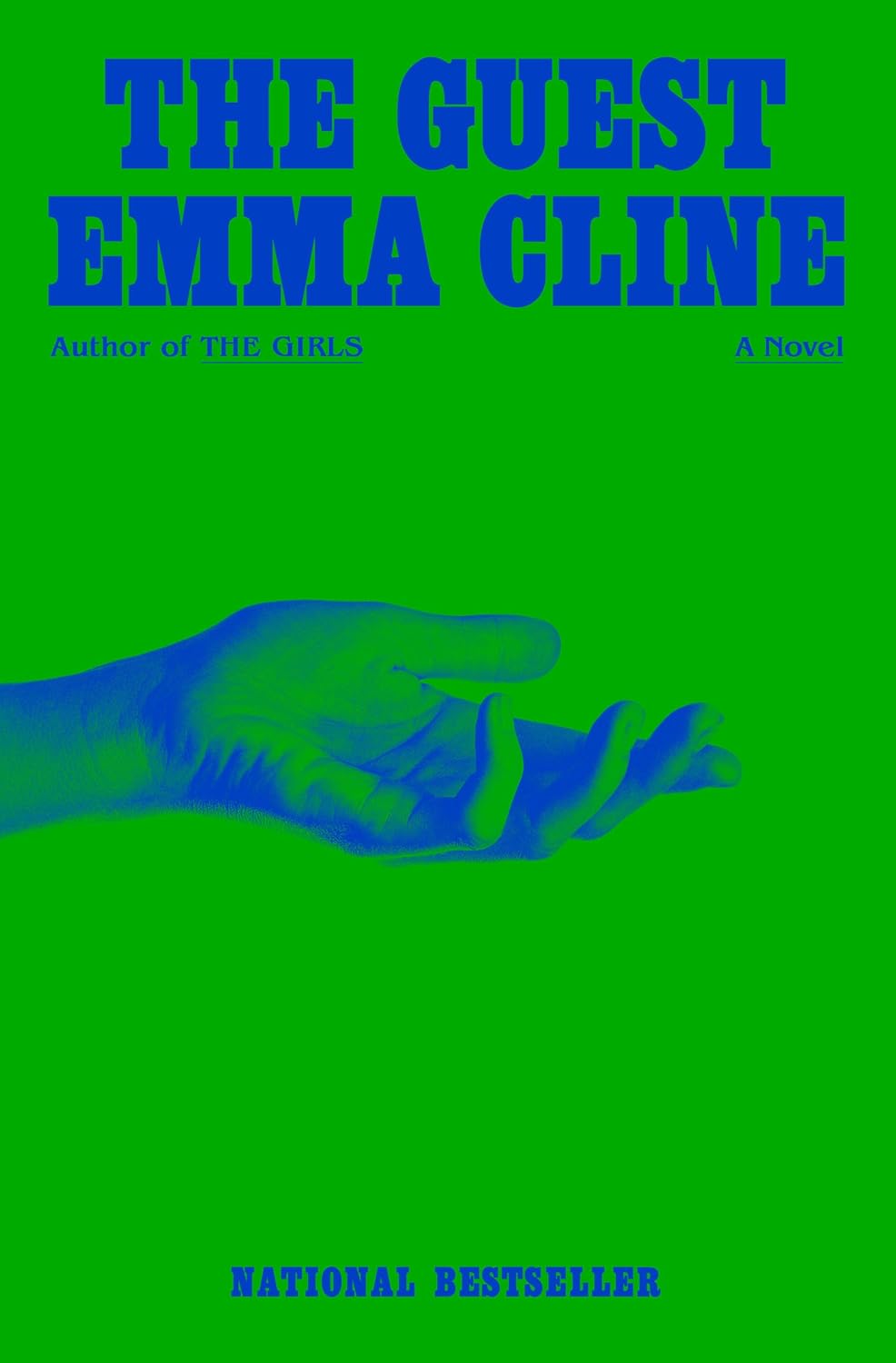 L’assenza di certezze e l’anti-performatività sociale
L’assenza di certezze e l’anti-performatività socialeÈ invece una weird girl letteraria e riflessiva – meno impulsiva di altre, ma profondamente alienata, autoanalitica, spesso inadeguata al mondo reale – Selin, protagonista di The idiot (2017) e di Either/or (2022) di Elif Batuman, pubblicati entrambi in Italia da Einaudi tra 2023 e 2024 con i titoli L’idiota e Aut-aut, e dedicati rispettivamente al racconto del primo e del secondo anno della protagonista come studentessa, figlia di immigrati turchi, ad Harvard. In Eithr/or, in particolare, Selin cerca di capire che tipo di vita vuole vivere: estetica o etica (ed ecco spiegato il riferimento a Kierkegaard del titolo). Vuole essere interessante, autonoma, libera, ma si scontra con l’ambiguità dei rapporti, i desideri imposti e le aspettative intellettuali. E così rilegge il suo anno precedente, i suoi fallimenti sentimentali, le sue ingenuità, con maggiore disincanto ma ancora senza certezze.
Di certezze è sprovvista anche, certamente, la protagonista di The guest di Emma Cline, pubblicato in lingua originale nel 2023 e ripreso da Einaudi nello stesso anno con il titolo L’ospite. Si chiama Alex, ha 22 anni e si muove tra le ville dei ricchi negli Hamptons fingendo di appartenere a quel mondo. Ma dopo essere stata scoperta e allontanata da una di queste residenze, si ritrova senza un posto dove andare e inizia a vagare, cercando di mantenere le apparenze e di sopravvivere in un ambiente che non le appartiene. Identità, alienazione, fragilità delle relazioni umane: tutti ingredienti della weird girl fiction.
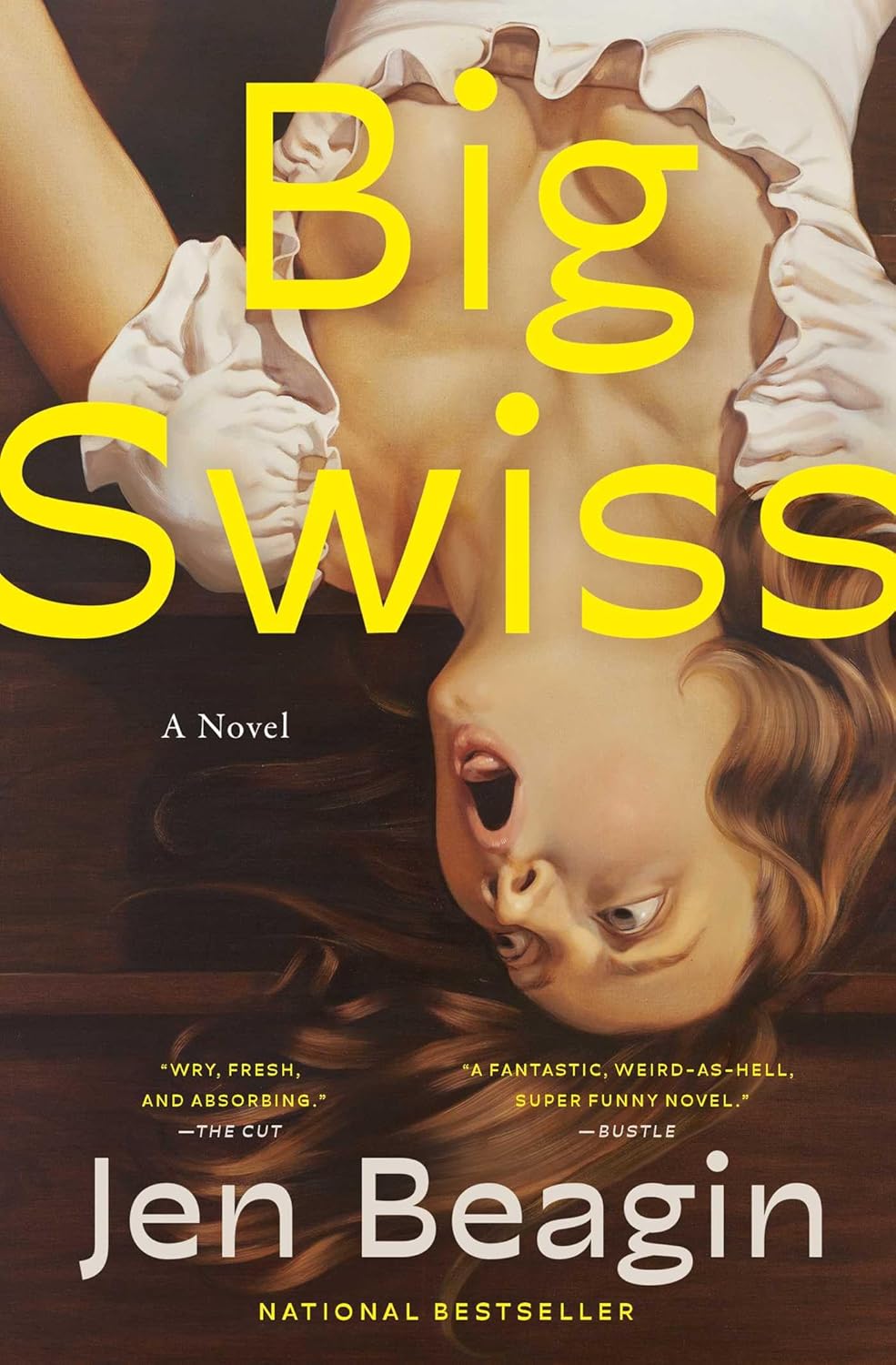 Non tutte le ragazze strane sono ragazze
Non tutte le ragazze strane sono ragazze
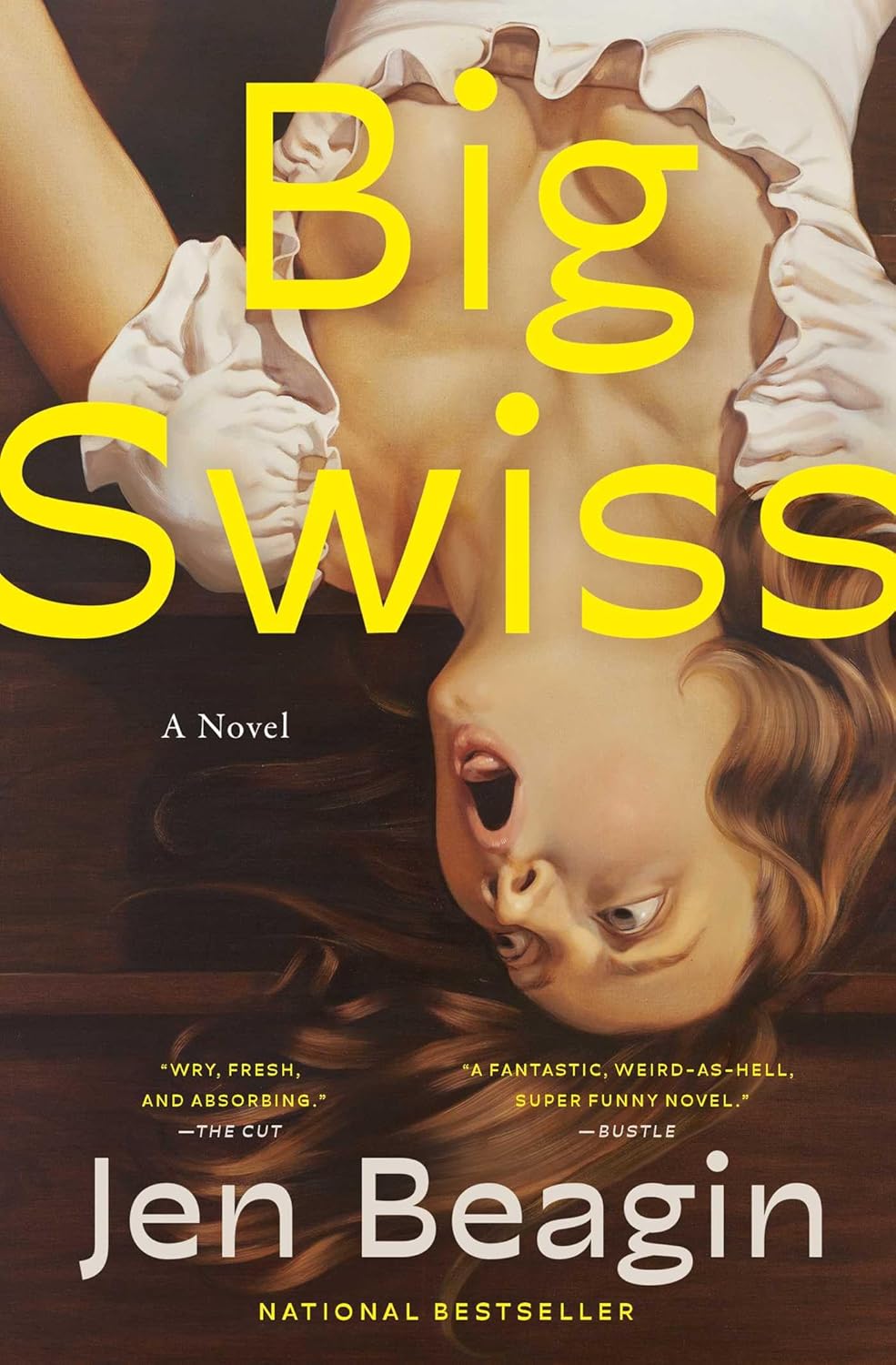 Non tutte le ragazze strane sono ragazze
Non tutte le ragazze strane sono ragazzeLe ragazze strane non sono necessariamente, anagraficamente, ragazze. Nightbitch di Rachel Yoder (2021, pubblicato in Italia nel 2023 da Mondadori e diventato all’inizio di quest’anno un film distribuito su Disney+), racconta la storia di una madre, ex artista, frustrata dalla routine domestica e dal peso invisibile della cura, che comincia a convincersi di stare diventando un cane. Letteralmente: le cresce il pelo, sviluppa un olfatto ipersensibile, ha desideri ferini. Ma invece di resistere, si lascia trasformare e scopre una nuova potenza.
In Big Swiss di Jen Beagin (2023) la protagonista è un’ultraquarantenne che per lavoro trascrive sedute di terapia per uno strano studio olistico. Greta, questo il suo nome, si ossessiona per una delle pazienti e finisce per incontrarla nella vita reale e sedurla, senza rivelarle di conoscerne i segreti più intimi. Ne nasce una relazione intensa, squilibrata, pericolosa e comica.
Ancora, in All fours di Miranda July (2024, tradotto in Italia da Feltrinelli con il titolo A quattro zampe) la protagonista è un'artista 45enne di Los Angeles che decide impulsivamente di intraprendere un viaggio in auto verso New York, lasciando marito e figlio a casa. Tuttavia, dopo appena mezz'ora di guida, farà un incontro che segnerà l'inizio di una profonda esplorazione interiore sul desiderio, l’invecchiamento e le aspettative sociali legate alla femminilità.
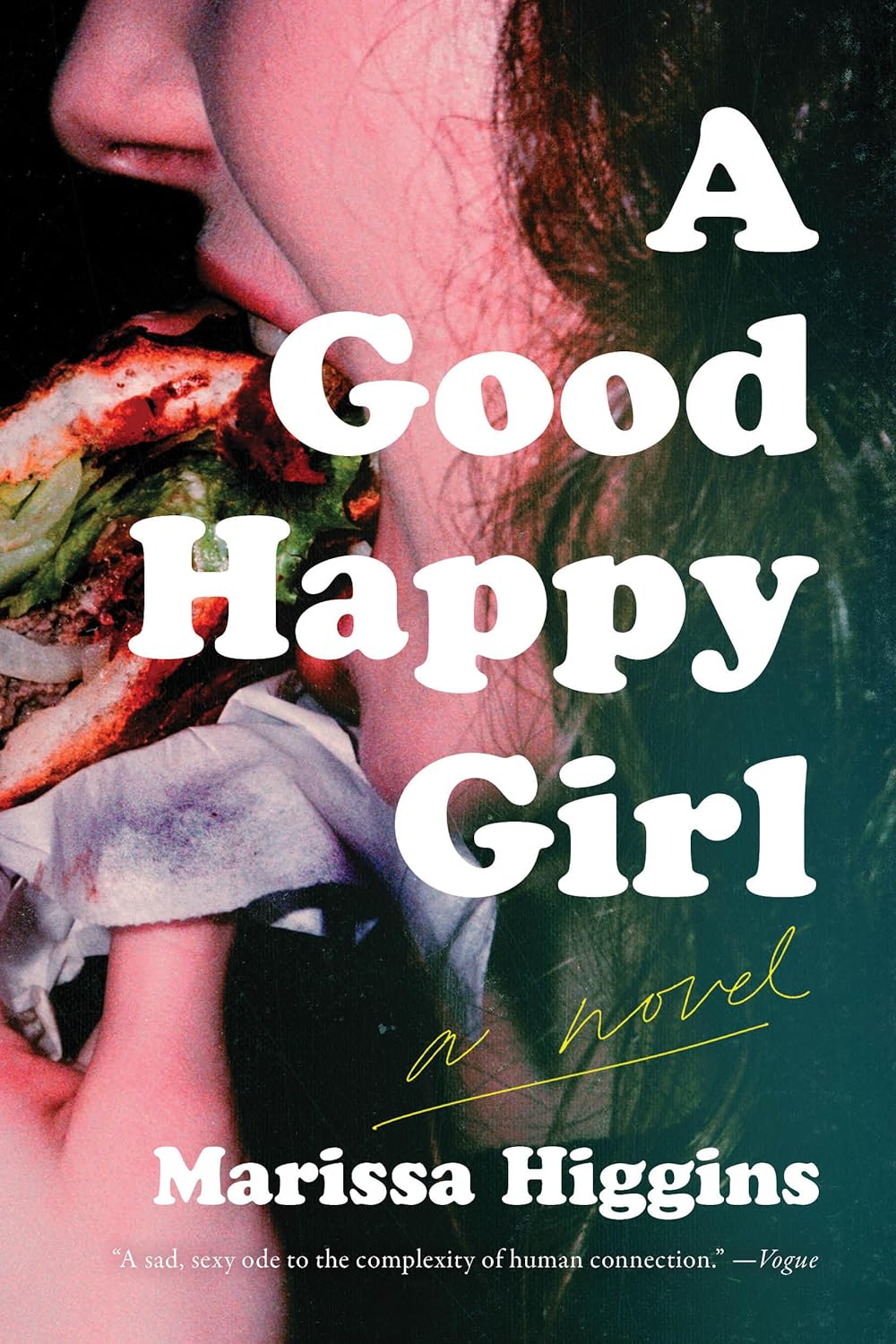 La queer weird girl lit-fic
La queer weird girl lit-ficSempre nel 2024 – legandosi questa volta al canone dalla «queer weird girl lit-fic» – è uscito A good happy girl, il romanzo d'esordio di Marissa Higgins: un'opera audace e provocatoria che esplora il desiderio, il trauma e le dinamiche familiari attraverso la lente di una protagonista queer e complessa. Ma pure Cecilia di K-Ming Chang, che s’inscrive allo stesso canone aggiungendo una nota surreale alla narrazione. Li ha preceduti entrambi You exist too much (2020) di Zaina Arafat, un romanzo di formazione intimo e tormentato, con una protagonista queer, palestinese-americana, che lotta tra desiderio, identità culturale e traumi familiari.
La weird girl fiction non è un genere
La weird girl fiction non è un genere, piuttosto una postura narrativa. Non si tratta semplicemente di «raccontare donne strane», ma di mettere in discussione la stessa idea di coerenza psicologica, di crescita, di redenzione dei personaggi femminili. In queste storie, il disordine non è da correggere ma da abitare. La weird girl non guarisce. Non si sistema. Non diventa una donna migliore. Ma ci obbliga a guardare quello che resta fuori dai margini.
Per la stessa ragione, la weird girl fiction è più di una moda. È una forma di resistenza, un modo per raccontare l’identità senza filtri, senza compiacimenti, senza bisogno di risultare «simpatica». In queste storie le donne non imparano lezioni, non si redimono, non diventano migliori. Spesso restano sole, sgradevoli, confuse. E proprio per questo ci somigliano più di quanto vorremmo ammettere.
Se la girlboss era l’ambiziosa, se la sad girl era la malinconica decorativa, la weird girl è la sopravvissuta. Abita un mondo disordinato, affettivamente scollegato, in cui la performance sociale è fallita e resta solo l’ineludibile verità.
Ecco, allora, forse, la weird girl fiction non chiede di capire le sue protagoniste. Chiede solo di restare con loro, anche quando fanno paura, anche quando ci fanno vergognare, anche quando vorremmo smettere di leggere.
Ecco, allora, forse, la weird girl fiction non chiede di capire le sue protagoniste. Chiede solo di restare con loro, anche quando fanno paura, anche quando ci fanno vergognare, anche quando vorremmo smettere di leggere.
L'autore: Alessandra Rotondo
Dal 2010 mi occupo della creazione di contenuti digitali, dal 2015 lo faccio in AIE dove oggi sono responsabile del contenuto editoriale del Giornale della Libreria, testata web e periodico in carta. Laureata in Relazioni internazionali e specializzata in Comunicazione pubblica alla Luiss Guido Carli di Roma, ho conseguito il master in Editoria di Unimi, AIE e Fondazione Mondadori. Molti dei miei interessi coincidono con i miei ambiti di ricerca e di lavoro: editoria, libri, podcast, narrazioni su più piattaforme e cultura digitale. La mia cosa preferita è il mare.
Guarda tutti gli articoli scritti da Alessandra Rotondo

















