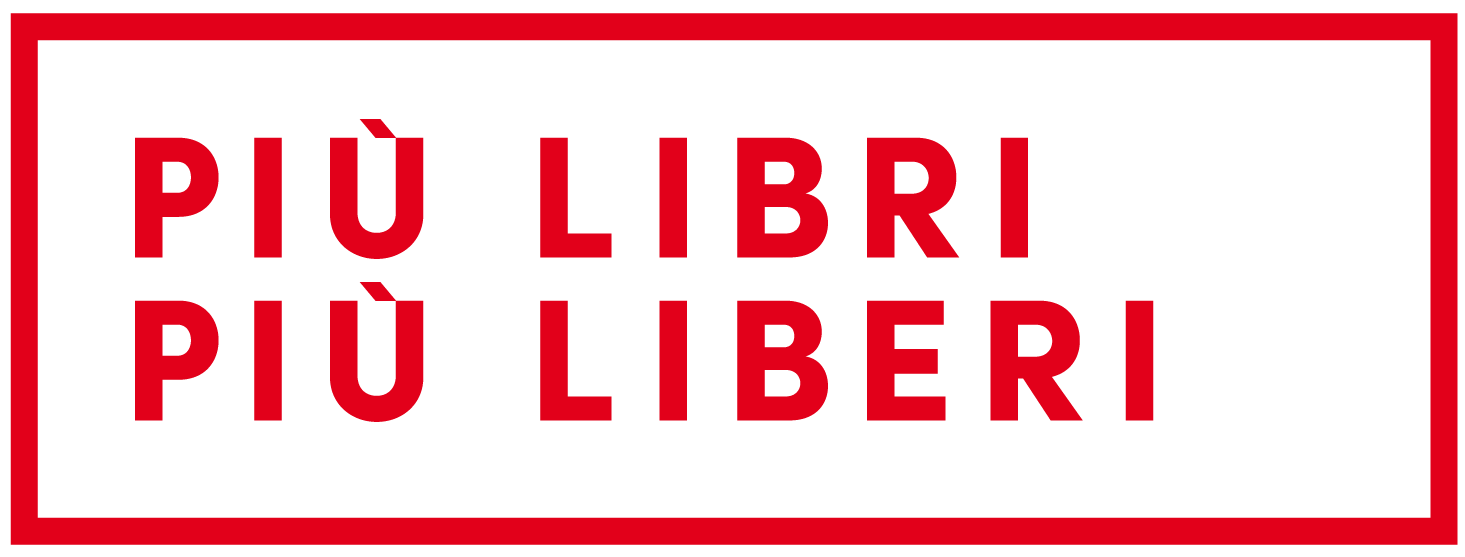
Il tessuto commerciale delle città –
abbiamo preso il caso di Roma come esempio, anche in considerazione del contesto in cui si svolge
Più libri più liberi, ma stiamo già iniziando a lavorare su Milano – si è profondamente trasformato in questi anni, con la chiusura di molti esercizi commerciali di prossimità e di vicinato, piccole botteghe «artigiane» – nella maggior parte dei casi a conduzione familiare – cui si sono sostituite insegne di moda e abbigliamento, arredo per la casa e ristorazione. E se un certo tipo di negozio «indipendente» (o presunto tale) continua ad aprire (o apre dal nuovo) i suoi battenti sulle vie del centro, manifestando spesso un’attitudine modaiola per il vintage e il design, il tessuto commerciale tradizionale delle nostre città presenta
un saldo in evoluzione, quando non in aperta perdita.
Anche le librerie sono state coinvolte in questo processo. E, almeno nel caso di Roma, il saldo è pesantemente negativo. Nelle aree centrali come in periferia: 223 chiusure in 10 anni. Dai 414 negozi che si contavano all’interno del GRA (Grande Raccordo Anulare) nel 2007 si è scesi a 191 nel 2017. Va detto che, se per il 2017 si è potuta fare una verifica (telefonica o sul sito web dell’attività commerciale) per accertare che proprio di libreria si trattava, lo stesso non si è potuto fare rispetto alla rete urbana delle librerie del 2007, ricostruita a partire da un indirizzario di «punti vendita trattanti i libri» che abbiamo potuto pulire solo guardando alle denominazioni ed eliminando quelle che «probabilmente» non erano librerie. È quindi ipotizzabile che il dato sia sovrastimato.

Il fenomeno è comunque evidente, e la tendenza è anche più accentuata rispetto a quella messa in luce da un’indagine condotta da Confcommercio sulle chiusure di punti vendita al dettaglio in sede fissa tra 2008 e 2016, che mostrava un -13,2% in generale e un -23,4% per i punti vendita che trattano libri e giocattoli.
Una trasformazione del commercio al dettaglio che, inevitabilmente, non poteva non coinvolgere anche le librerie. Forse il caso di Roma – che abbiamo avuto la possibilità di approfondire con l’aiuto della professoressa Francesca Vannucchi dell’Università di Tor Vergata e con i suoi studenti – può presentare elementi di peculiarità legati al forte impatto che il turismo ha sui valori immobiliari dell’esercizio commerciale; alle dinamiche sociali e urbane che tutti conosciamo; ai vincoli urbanistici e di tutela del patrimonio che nel centro storico rendono difficili gli ampliamenti… Ma resta comunque un buon punto di osservazione di un processo che non sappiamo quanto sia esteso, né con quali caratteristiche: viene da chiedersi, ad esempio, se a Venezia o a Firenze abbia avuto lo stesso impatto, anche in considerazione della loro forte e tradizionale vocazione al turismo, nazionale e internazionale.
È un processo, questo ci è assolutamente chiaro, non ignorabile da un punto di vista culturale. La crescita e la qualificazione dei tessuti urbani, infatti, non può che passare anche attraverso politiche capaci di favorire lo sviluppo del retail. Un retail moderno, certo, ma anche aperto ad accogliere la molteplicità (e l’eterogenia) delle occasioni di vendita e di acquisto dei prodotti, tra cui i libri. Un retail che innalzi la diversità a elemento di ricchezza e coesione sociale: che diventi parte integrante e connettore di quel tessuto urbano nel quale va a inserirsi. Nei centri storici come nelle periferie.
Oggi, a Più libri più liberi, nell’ambito di un incontro introdotto da
Annamaria Malato (Salerno Editrice, Consiglio Piccoli editori Aie) dal titolo molto evocativo
– Le librerie che tengono assieme le città,
puoi scaricare alcuni dei materiali presentati a questo link – abbiamo guardato da vicino a quelle librerie e a quei librai che sembrano indicare i primi segnali di cambiamento (
Alessandro Alessandroni di Altroquando e
Davide Vender di Odradek, in particolare). Di altri ancora abbiamo conosciuto il parere in video, grazie al lavoro degli studenti dell’Università di Tor Vergata.
Senza dimenticare la dimensione politica di questa dinamica e di questo discorso: non era casuale la presenza all'incontro del Consigliere regionale del Lazio Gian Paolo Manzella. Tanto più che la distribuzione delle librerie (già nel 2007, ma ancora di più dieci anni dopo) penalizza – tra quelle che chiudono e quelle che comunque resistono – la gran parte della periferia cittadina, come mostrano con fin troppa evidenza le mappe.
Mi sono sempre occupato di questo mondo. Di editori piccoli e grandi, di libri, di librerie, e di lettori. Spesso anche di quello che stava ai loro confini e a volte anche molto oltre. Di relazioni tra imprese come tra clienti: di chi dava valore a cosa. Di come i valori cambiavano in questi scambi. Perché e come si compra. Perché si entra proprio in quel negozio e si compra proprio quel libro. Del modo e dei luoghi del leggere. Se quello di oggi è ancora «leggere». Di come le liturgie cambiano rimanendo uguali, di come rimanendo uguali sono cambiate. Ormai ho raggiunto l'età per voltarmi indietro e vedere cosa è mutato. Cosa fare da grande non l'ho ancora perfettamente deciso. Diciamo che ho qualche idea. Viaggiare, anche se adesso è un po' complicato. Intanto continuo a dirigere l'Ufficio studi dell'Associazione editori pensando che il Giornale della libreria ne sia parte, perché credo sempre meno nei numeri e più alle storie che si possono raccontare dalle pagine di un periodico e nell'antropologia dei comportamenti che si possono osservare.
Guarda tutti gli articoli scritti da Giovanni Peresson



















